
Trebisacce-27/12/2021: L’analisi del XIII canto di Pier delle Vigne dell’Inferno di Dante (di Salvatore La Moglie)



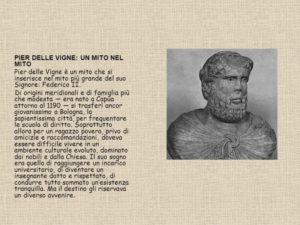
Rubrica letteraria a cura di Salvatore La Moglie
Pubblichiamo qui di seguito l’analisi del XIII canto di Pier delle Vigne dell’Inferno di Dante, del quale Salvatore La Moglie propone un nuovo e originale commento che è diventato un libro pubblicato dalla casa editrice Setteponti di Arezzo. Questa volta i protagonisti sono i suicidi. Alla fine, però, troviamo anche la categoria umana degli scialacquatori
Il XIII canto-capitolo ovvero il canto di Pier delle Vigne, vittima di un’ingiustizia e di una congiura da macchina del fango. Siamo sempre nel regno della Malizia, nel settimo cerchio e nel secondo girone. I suicidi (violenti contro se stessi, nella persona): sono trasformati in piante, in pruni e, siccome si tolsero da sé il proprio corpo, non potranno più riaverlo. Ci sono anche gli scialacquatori (violenti nelle cose): sono inseguiti, straziati e fatti a pezzi da fameliche cagne nere, loro che in vita dilapidarono e scialacquarono i loro beni.
Il tredicesimo canto-capitolo si apre con Nesso che se n’è appena andato via e i due Poeti che si immettono per un orribile bosco, una terrificante e quasi inaccessibile selva, senza alcun sentiero da poter seguire: Non era ancor di là Nesso arrivato, quando noi ci mettemmo per un bosco che da nessun sentiero era segnato. La descrizione del terrorizzante paesaggio che i due si trovano davanti è anch’essa da film di horror o da romanzo noir che ti resta scolpita nella mente e negli occhi. E Dante fa di tutto per rendere realistica la scena e visibili i personaggi e l’ambiente che li circonda; è come se dicesse: vorrei che tu, lettore, li vedessi come li ho visti io! Perché lui ci ha già detto che tutto quello che racconta l’ha realmente visto con i suoi occhi (o mente che scrivesti ciò ch’io vidi, canto II dell’Inferno). E, dunque, ecco cosa ci fa vedere Dante con le parole (e sono parole che vanno lette con climax ascendente): Non fronda verde, ma di color fosco; non rami schietti, ma nodosi e ‘nvolti; non pomi v’eran, ma stecchi con tosco: non han sì aspri sterpi né sì folti quelle fiere selvagge che in odio hanno tra Cecina e Corneto i luoghi colti. Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno, che cacciar delle Strofade i Troiani con tristo annunzio di futuro danno. Ali hanno late, e colli e visi umani, piè con artigli, e pennuto il gran ventre; fanno lamenti in su li alberi strani.
Siamo nel secondo girone del settimo cerchio è il paesaggio è davvero strano, da incubo, terribilmente, desolante e impressionante: la vegetazione non ha rami verdi ma solo oscuri, contorti, intrecciati, nodosi, privi di alcun frutto ma solo muniti di spine velenose. Gli animali selvatici che tra Cecina e Corneto, ovvero tra la Maremma toscana e quella romana, evitano i luoghi coltivati, non hanno come dimora, come tana un luogo pieno di sterpi e una vegetazione come quella. Però, qui fanno i loro nidi le ripugnanti e sudice Arpie, le mitologiche figlie di Elettra e di Taumante, con volto di donna e corpo di uccello rapace, che furono costrette dai figli di Borea a rifugiarsi e nascondersi nelle isole Strofadi, nel Mar Jonio. Secondo la leggenda e secondo Virgilio, pare che le Arpie sporcarono con il loro sterco le mense di Enea e dei suoi compagni che erano giunti nelle Strofadi; non solo ma una di esse, Celeno, profetizzò ai Troiani un futuro di disgrazie, dolore e soprattutto di fame. Le Arpie hanno ali larghe, collo e volto umani, di donne; le zampe muniti di artigli e il ventre grande e ben ricoperto di penne; quando sono sugli alberi, emettono insoliti e terrificanti lamenti.
Virgilio dice a Dante che si trova nel secondo girone e che ci resterà ancora fino a quando non si giungerà nell’orribil sabbione, cioè nel terzo girone, dove sono puniti i violenti contro Dio e, pertanto, stai ben attento, rifletti bene perché ti succederà di vedere cose che se io te le dicessi, tu non ci crederesti, perché ti sembrerebbero incredibili (cose che torrìen fede al mio sermone, cioè al mio discorso, alle mie parole). Dante ci fa sapere che sente da ogni parte uscire dei lamenti senza vedere, però, chi si lamentasse, tanto che, smarrito e turbato, si ferma e pensa: Cred’io ch’ei credette ch’io credesse che tante voci uscisser tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse, e cioè (con un bel gioco di parole, con un bel gioco di retorica) Dante dice: credo che Virgilio abbia creduto che io credessi che suoni e lamenti uscissero tra quegli sterpi da anime che a noi fossero invisibili e, quindi, nascoste. Perciò il maestro gli dice: Se tu tronchi qualche fraschetta d’una d’este piante, li pensier c’hai si faran tutti monchi: se spezzi uno dei ramoscelli di una di queste piante, i dubbi che hai saranno troncati anch’essi, cioè verranno meno. Dante è ansioso e timoroso, ma a prevalere è sempre la sua grande curiosità e così allunga la mano e strappa (colsi) un ramoscello da un grande pruno e dal suo fusto esce subito un grido di dolore (e ‘l tronco suo gridò): Perché mi schiante? Perché mi spezzi? E dopo che, dalla ferita, era uscito sangue scuro (sangue bruno) che macchiacava il ramo, riprese a dire: Perché mi scerpi? non hai tu spirto di pietà alcuno? Uomini fummo, e or siam fatti sterpi: ben dovr’ebbesser la tua man più pia, se state fossimo anime di serpi: Perché mi laceri? non hai nessun sentimento di pietà, di umanità? Noi siamo stati uomini e ora siamo diventati piante: la tua mano dovrebbe essere pietosa persino se fossimo state anime di (animali ripugnanti come i) serpenti (e, dunque, a maggior ragione per il fatto che siamo anime di uomini…).
A parlare in maniera così risentita è un essere umano, Pier delle Vigne (o della Vigna), di Capua e di famiglia alquanto disagiata; cancelliere e consigliere di Federico II di Svevia per quasi vent’anni, nonché giurista, esperto in lingua latina e rimatore in volgare. Il suo potere presso la Corte fu enorme soprattutto dal 1246, quando fu nominato protonotaro e logoteta, cioè segretario e portavoce imperiale. Calunniato dagli invidiosi della Corte, uniti in una sorte di congiura per eliminarlo dalla scena politica, fu fatto accecare e imprigionare dall’imperatore e, lui, che si riteneva innocente e ingiustamente accusato e offeso nell’onore pensò (secondo una leggenda) di mettere fine al disonore che cadeva sulla sua persona uccidendosi in carcere correndo verso il muro della prigione che aveva di fronte a lui, fatto di robuste pietre, e facendo sbattere violentemente la testa.
Pier delle Vigne cerca di colpire Dante nel suo sentimento di pietà e di umanità e il Poeta sa che di questo sentimento è ricco, anzi ricchissimo; la sua è stata soltanto curiosità e non cattiveria: non poteva immaginare il fatto assolutamente insolito e inedito dell’anima di un uomo trasformata in una pianta; non poteva immaginare che a lui si ripresentasse, come ad Enea, il caso dell’anima di Polidoro (figlio di Priamo, re di Troia) conficcata dentro una pianta e da cui l’eroe troiano strappa un rametto. Ma il caso è ben diverso, anche se molto citato dai commentatori.
Dunque, per contrappasso, i suicidi hanno la loro anima imprigionata in un arbusto, in una pianta spinosa, loro che, sulla Terra, non seppero tenere ben stretto il bene più prezioso, la vita (e, quindi, il loro corpo) offendendo anche Dio che l’ha data. La pena inflitta è terribile e dolorosissima; la legge del contrappasso è applicata per contrasto: come in vita si separarono violentemente dal loro corpo, adesso la loro condizione umana (viene sempre da dire…) è quella di anime condannate in eterno a stare conficcate in una pianta anche molto brutta nell’aspetto e anche dopo il Giudizio universale (come il protagonista spiegherà, alla fine, ai due Poeti), per cui i suicidi non potranno riavere il loro corpo poichè non è giusto aver ciò ch’om si toglie: i corpi saranno da loro trascinati nella mesta selva e resteranno appesi, in eterno, al pruno che imprigiona le loro anime (ciascuna al prun de l’ombra sua molesta, in quanto ostile al corpo dal quale decise di separarsi, come il protagonista spiega, richiesto da Virgilio-Dante). Dalla natura umana, dalla quale si vollero separare, sono passati per sempre alla natura vegetale. Inoltre, i suicidi sono molestati e infastiditi dalle terrificanti Arpie e anche dalle anime degli scialacquatori che, braccate da orribili cagne nere, corrono all’impazzata travolgendo i rami delle anime-sterpi, delle anime-piante.
Dante prosegue la sua narrazione con una delle sue azzeccate similitudini: Come d’un stizzo verde ch’arso sia dall’un de’ capi, che dall’altro geme e cigola per vento che va via, sì dalla scheggia rotta usciva inseme parole e sangue; ond’io lasciai la cima cadere, e stetti come l’uom che teme: Come accade che un ramo verde che da una parte arde e dall’altra emette la linfa, perché deve eliminare l’umidità che contiene e, quindi, cigola, rumoreggia, sibila, così, allo stesso modo, dal punto in cui il rametto è stato strappato, uscivano parole e sangue, cioè si sentiva gemere qualcuno, per la qual cosa io ho lasciato subito cadere il ramoscello e sono rimasto (fermo e impietrito…) come colui che ha paura. E, in verità, non accade tutti i giorni una scena come quella che vede lo sbigottito Dante e, alle parole risentite dell’anima dolente, replica subito Virgilio perché Dante è ancora lì allibito e come pietrificato, non riesce a credere ai suoi poveri occhi e non riesce neppure a chiedere scusa all’interlocutore per il suo gesto non dettato da cattiva intenzione, non diretto a fargli del male: S’elli avesse potuto creder prima anima lesa, ciò c’ha veduto pur con la mia rima, non avrebbe in te la man distesa; ma la cosa incredibile mi fece indurlo ad ovra ch’a me stesso pesa. Ma dilli chi tu fosti, sì che ‘n vece d’alcun’ammenda, tua fama rinfreschi nel mondo su dove tornar li lece: o anima offesa, se Dante (s’elli) avesse creduto subito a quello che ha visto già solo attraverso i miei versi, il mio poema (dove si parla di Polidoro), invece (sottinteso) di volere una prova concreta, non avrebbe certo allungata la mano e strappato un tuo ramoscello; ma il fatto era così incredibile tanto da indurlo (mio malgrado…) ad un atto, a un gesto che anche a me pesa e rincresce molto. Comunque, tu digli (a Dante) chi sei stato nella vita terrena, di modo che, come risarcimento per l’offesa che ti ha arrecato, egli possa rinverdire, rinnovare la tua fama presso gli uomini di quel mondo dove gli è consentito di ritornare in quanto è vivo.
Le parole di Virgilio (adeguate a un personaggio così bravo nell’uso della parola scritta e parlata e non prive di quella captatio benevolentiae, che pure altre volte utilizzerà per ingraziarsi i peccatori e spingerli a confessarsi e a vuotare il sacco) sembrano aver fatto centro e Pier delle Vigne appare subito ben disposto a perdonare l’errore di Dante, commesso in buonafede e non in malafede: Dante rappresenta per lui un’occasione imperdibile perché, ritornando nel mondo dei vivi, potrà ristabilire la verità, riabilitarlo e rendergli finalmente giustizia per il torto subìto e la calunnia infame che lo ha presentato agli occhi del suo imperatore e del mondo come un vile traditore e poi condotto alla tragedia della prigionia e, infine, alla scelta (forzata…) e alla decisione terribile di togliersi la vita come gesto di ribellione, di rivolta contro un’ingiusta offesa e calunnia ad opera di uomini malvagi e invidiosi della sua posizione presso la Corte dello Stupor Mundi che, comunque, alle basse calunnie di altri uomini del suo entourage pare avesse creduto. E, dunque, questo il triste racconto dell’anima-pianta di Pier delle Vigne nel quale, probabilmente, Dante si immedesima e come lui si sente vittima dell’invidia dei suoi concittadini, di un’ingiustizia e di una montatura da macchina del fango (come diciamo oggi) diretta a gettare discretito sulla sua persona per demolirla: Sì col dolce dir m’adeschi, ch’i’ non posso tacere; e voi non gravi perch’io un poco a ragionar m’inveschi. Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federigo, e che le volsi, serrando e disserrando, sì soavi, che dal secreto suo quasi ogn’uom tolsi: fede portai al glorioso offizio, tanto ch’i ne perde’ li sonni e’ polsi. La meretrice che mai dall’ospizio di Cesare non torse li occhi putti, morte comune, delle corti vizio, infiammò contra me li animi tutti; e li ‘nfiammati infiammar sì Augusto, che’ lieti onor tornaro in tristi lutti. L’animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Per le nove radici d’esto legno vi giuro che già mai non ruppi fede al mio signor, che fu d’onor sì degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia, che giace ancor del colpo che ‘nvidia le diede.
Dice Pier delle Vigne: Siccome mi alletti con parole così cortesi, io non posso starmene zitto; e quindi non vi dispiaccia se mi metto a parlare un po’ con voi. Io sono (Pier delle Vigne) colui che (parla per metafore) teneva entrambe le chiavi del cuore di Federico che diceva sì oppure no, concedeva o rifiutava a seconda del mio consiglio; e tanta era la mia capacità di persuasione, che io aprivo e chiudevo così soavemente, dolcemente queste chiavi che decidevano se volere o non volere, decidere o non decidere su qualunque cosa… Era tanta la fiducia che egli aveva in me che nessun altro poteva essere nella mia posizione di un rapporto così privilegiato, ma io sono stato fedelissimo nello svolgere il mio incarico così prestigioso, onorevole e glorioso (quasi riflesso della gloria imperiale dalla quale proveniva), tanto da perdere il sonno e la salute, la tranquillità e la vita stessa (perché l’uomo avvertiva il grande peso di tanto incarico e di tanta fiducia). Ma accadde che quella grande prostituta che è l’invidia (dei mediocri e dei malvagi, verrebbe da aggiungere…), l’invidia che è un terribile male così diffuso tra gli esseri umani e vizio di tutte le Corti, tanto che mai ha distolto il suo sguardo insinuante e disonesto dalla sede del potere imperiale… ebbene l’invidia accese gli animi di tutti i cortigiani che, essendo accesi nel loro basso sentimento, furono così capaci di insinuare dubbi e sospetti nell’imperatore da accendere pure lui e convincerlo del mio (presunto…) tradimento.
La calunnia ben costruita riesce ad infiammare, accendere gli animi. Scriverà, più di quattro secoli dopo, l’illuminista Voltaire che la calunnia è come la brace che, non potendo bruciare il legno verde , lo annerisce, cioè gli lascia una brutta macchia nera. La montatura e la macchina del fango, direbbe oggi Pier delle Vigne, funzionarono così bene che gli onori che rendevano lieta la mia vita, si trasformarono in disgrazie e in dolori (perché venne esonerato da ogni incarico, incarcerato e poi abbacinato) e, perciò, nel mio animo così amareggiato, maturò la scelta, la decisione sofferta di porre fine alla mia esistenza: ero così indignato da credere e concludere che solo morendo avrei potuto evitare l’indignazione, lo sdegno e il biasimo dell’imperatore e di quanti erano convinti del mio presunto tradimento e quindi della mia presunta ingratitudine nei confronti di Federico… Così decisi di compiere un atto (il suicidio) che fece di me, uomo giusto, un uomo ingiusto (compiendo un atto contro natura e contro Dio). Proprio per tutto quello che vi ho raccontato, vi giuro (ed è giuramento solenne), per le recenti radici di questa pianta in cui sono imprigionato (perché è morto da non molto tempo, nel 1294), che non ho mai tradito il mio imperatore, che fu così degno di essere onorato (e mostra di non provare alcun rancore nei confronti di Federico, ma semmai soltanto verso gli invidiosi cortigiani che lo hanno fomentato e saputo insospettire). E se uno di voi ritorna nel mondo, lo prego di riabilitarmi, di rinverdire la memoria che la gente (l’opinione pubblica, diremmo oggi, e poi quella dei posteri) ha di me, che è stata demolita e infangata dal colpo infertole dall’invidia…
Pier delle Vigne ha finito il suo amaro, commovente e conturbante racconto della sua vita giunta all’apice della potenza e poi distrutta dalla macchina del fango messa in moto dall’invidia di cortigiani che seppero convincere Federico della sua presunta infedeltà e della sua ingratitudine. Così, decide di trovare uno sbocco all’ingiusto disonore e al pubblico disprezzo (la gogna mediatica, diremmo oggi) nel suicidio come rivolta morale e come gesto di protesta che dovrebbe riscattare dalle terribili accuse. Il suicidio non è certo un esito felice per qualsiasi esistenza, aldilà del credere o meno che la vita ci è stata da Dio e che spetta a Lui togliercela. Il suicidio può essere considerato come un gesto di debolezza, di umiltà o di forza. Decide di togliersi la vita colui che essendo molto debole di fronte alla realtà e a certi particolari eventi, non se la sente di affrontarli, non ce la fa, prova un sentimento d’impotenza tale che non potrà che soccombere. Si può decidere di togliersi la vita per un sentimento di umiltà di fronte a tutto quello che accade su questo mondo e non ci piace, come non ci piace la nostra esistenza e, allora, abbiamo il caso di Cesare Pavese che non decide di porre fine alla sua vita per debolezza quanto per umiltà: ci vuole umiltà, non orgoglio. Tutto questo fa schifo, ecc. Un’umiltà che è il frutto di un ragionamento, di tutta una visione (negativa) della vita e la presa d’atto del suo nonsenso. E, poi, c’è il suicidio come atto di coraggio, di rivolta morale, di ribellione, di sfida, di protesta, di rifiuto sdegnoso nei confronti di ingiuste accuse infamanti, insomma il suicidio come gesto di forza, forza spirituale e morale, il suicidio come forte sentimento di libertà e di liberazione. Si pensi al gesto coraggioso del foscoliano Jacopo Ortis o a quello del pagano Catone l’Uticense (oppositore di Cesare messo da Dante a custode del secondo Regno!) che preferisce la morte alla perdita della libertà politica (e, dunque, simboleggia la libertà in senso assoluto e, quindi, la libertà interiore, spirituale, la libertà dal peccato e figura di Cristo, secondo Auerbach). Nel canto I del Purgatorio, a giustificazione morale del suo suicidio, Dante (che si riconosce, identifica in lui) scrive: Libertà va cercando ch’è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta. E gesto coraggioso e di protesta morale è quello di Pier delle Vigne, che Dante condanna e assolve nello stesso tempo, ristabilendo la verità sul suo pietoso caso frutto del complotto di malvagi senza scrupoli. Ma se gli uomini e la Storia commettono impunemente le loro violenze e le loro ingiustizie sui popoli e sulle umane esistenze, la Letteratura si assume il compito di ristabilire la verità, di riportare le cose nei loro giusti termini e, quindi, di rendere giustizia alle vittime.
Finito il triste racconto di Pier delle Vigne, l’empatico e umanissimo Dante è talmente preso da pietas e da pathos, da grande angoscia e commozione, che non riesce a dire una parola e prega Virgilio di chiedergli quello che lui pensa possa soddisfare la sua curiosità, come accade altre volte durante il viaggio. Virgilio gli chiede il destino dei suicidi da quando vanno all’Inferno fino a quando ci sarà il Giudizio Universale ma, finito il colloquio, sono sorpresi da un forte rumore e da una sorta di fuggi-fuggi, di inseguimento come quando si dà la caccia a un cinghiale e si sentono rumori di ogni genere. Ad essere braccati, però, non sono i cinghiali. All’improvviso, appaiono, sul lato sinistro della orribile e incredibile scena infernale, due anime nude e piene di graffi (la nudità indica ancora una volta la povertà morale e spirituale e l’impossibilità dei dannati di farla franca, di evitare le sofferenze imposte dalla pena loro inflitta). Le due anime (veramente sembrano corpi, uomini in carne ed ossa…), inseguite da cagne nere e affamate, corrono velocissime, tanto da spezzare e travolgere ogni ramo che capita nella loro corsa. Gli eternamente inseguiti e sbranati da terrificanti cagne nere sono due scialacquatori. Uno è il senese Lano o Arcolano di Squarcia Maconi, ricchissimo ma gran dissipatore, in breve tempo, del suo patrimonio; si dice che fu ucciso nella battaglia del Pieve del Toppo (1287) contro gli Aretini ma, secondo Boccaccio, pare che andò incontro ai nemici per cercarvi la morte. L’altro è Jacopo, ovvero Giacomo da Sant’Andrea di Codiverno (Padova), figlio di Oderico di Monselice: al servizio di Federico II, fu fatto uccidere da Ezzelino da Romano nel 1239. Anch’egli molto ricco, pare che, per stravaganza, un giorno fece bruciare una sua villa per poter vedere un grande falò…
E, così, l’anima che nella corsa è più vicina a i due Poeti, cioè Lano, grida augurandosi di morire anche spiritualmente per non soffrire più (la morte seconda, che ritorna spesso nell’Inferno): Or accorri, accorri, morte! E Jacopo, che sembra non essere tanto veloce nella fuga, nel correre, grida a sua volta: Lano, sì non furo accorte le gambe tue a le giostre dal Toppo! Lo prende in giro, fa ironia: mio caro, le tue gambe non sono state così veloci durante la battaglia di Pieve del Toppo! Sottinteso: se lo fossero state, non saresti morto e ora qui a dartela a gambe!… Non c’è neppure solidarietà tra i dannati nello scontare la pena e, siccome i loro difetti da vivi continuano, si confermano anche nell’Oltretomba, vediamo Jacopo che ironizza fino al sarcasmo più grottesco sulle gambe di Lano…
Jacopo, però, mostra di perdere le forze, il respiro (e poi che forse li fallìa la lena), e tenta il tutto per tutto per evitare l’aggressione delle terribili cagne nere: cerca di nascondersi e di mimetizzarsi in un’anima-pianta, un’anima-cespuglio, come ad essere un tutt’uno con essa (di sé e d’un cespuglio fece un groppo). Dietro le due sventurate anime ci sono tante cagne nere, affamate e veloci come veltri scatenati (nere cagne, bramose e correnti come veltri ch’uscisser di catena), che riempiono spaventosamente e rumorosamente la selva. Le cagne mostruose scoprono l’anima incespugliata di Jacopo e la sbranano, dilacerano, la fanno a pezzi straziandola e portandosi via le membra doloranti e ridotte a pezzetti: In quel che s’appiattò miser li denti, e quel dilaceraro a brano a brano; poi sen portar quelle membra dolenti. Ma le cagne hanno anche dato morsi ai rami, hanno strapazzato alquanto l’anima-arbusto, l’anima-pruno dove Jacopo si è riparata per evitare l’assalto delle cagne. Dante è evidentemente spaventato da quella scena di caccia infernale e Virgilio, infatti, lo prende per mano come fa ogni volta che deve rassicurarlo. Lo porta vicino al cespuglio che piangea, per le rotture sanguinenti, invano: piange inutilmente, nel senso che la scena, purtroppo, si ripeterà in eterno e, nell’Inferno, il pianto è vano; però, quell’invano può intendersi anche così: piangeva per le lacerazioni provocate dal fatto che Jacopo si è nascosto inutilmente nel cespuglio: non avrebbe evitato, in ogni modo, di essere fatto a pezzi dalle cagne, anche perché tale contrappasso per analogia lo vuole la Giustizia divina: come gli scialacquatori in vita sperperarono, dilapidarono, dissiparono con leggerezza, stravaganza e irrazionalità i loro beni e le loro ricchezze, così, nell’Inferno, sono eternamente puniti con il veder straziate, fatte a pezzi, sparse di qua e di là le loro membra che, dopo, devono cercare di ricomporre per poi essere nuovamente dilacerate e disperse…
E, dunque, l’anima-cespuglio, piangendo, dice rivolgendosi a chi gli ha procurato ulteriore inutile sofferenza: O Giacomo da Santo Andrea, che t’è giovato di me fare schermo? che colpa ho io della tua vita rea? Non ti è servito a nulla cercare di trovare riparo dietro di me e, poi, io non ho nessuna colpa della tua vita malvagia… Come dire: non hai fatto altro che causarmi altre sofferenze oltre a quella per cui sono chiamato qui a pagare per l’eternità…
Quando Virgilio è abbastanza vicino all’anima-cespuglio gli domanda chi egli sia: Chi fosti, che per tante punte soffi con sangue doloroso sermo? Chi sei tu che parli dolorosamente attraverso le ferite dei tuoi rami spezzati? Risposta: O anime che giunte siete a veder lo strazio disonesto c’ha le mie fronde sì da me disgiunte, raccoglietele al piè del tristo cesto. I’ fui della città che nel Batista mutò il primo padrone; ond’e’ per questo sempre con l’arte sua la farà trista; e se non fosse che ‘n sul passo dell’Arno rimane ancor di lui alcuna vista, quei cittadin che poi la rifondarno sovra ‘l carcere che d’Attila rimase, avrebber fatto lavorare indarno. Io fei giubbetto a me delle mie case. Questa la triste e malinconica conclusione dell’anima del suicida e la scena della solitaria impiccagione sembra di vederla. Secondo alcuni commentatori, a parlare sarebbe Lotto degli Agli (priore di Firenze e giudice che si sarebbe ucciso per il rimorso di aver emessa un’ingiusta sentenza di morte tra il 1293 il 1295) e, per altri, Rocco de’ Mozzi (altro contemporaneo di Dante) che, dopo aver dilapidato quasi tutti i suoi averi, si impiccò nella propria casa, proprio come dice alla fine del racconto l’anima offesa e risentita per le inutili ferite: far giubbetto o gibetto era un francesismo (gibet cioè patibolo, forca) che Dante, nella sua modernità e nel suo sperimentalismo linguistico, accoglie per dire che si era impiccato a una trave della propria abitazione.
Dunque, il suicida si lamenta dell’ingiusto, indecoroso e crudele strazio delle proprie membra e prega i due Poeti di raccoglierle e di deporle ai piedi dell’infelice e sventurato cespuglio che incarcera la propria anima. Dice di essere di Firenze, la città che ha mutato il suo primo pagano protettore, patrono (Marte) mettendo al suo posto San Giovanni Battista e, per questo fatto, Marte si vendicherà con la guerra (che è la sua arte) rendendo infelice la città e i suoi abitanti (altra triste profezia su Firenze e i suoi malvagi abitanti). Non solo: …se non fosse che ancora rimane sul Ponte Vecchio all’Arno un frammento della Statua del dio, questi avrebbe già tutta distrutta la città, rendendo vana la fatica di coloro che la riedificarono dopo che Attila l’aveva messa a ferro e fuoco (Sapegno). Ma la leggenda che vuole Firenze esser stata distrutta da Attila pare non reggere: fu il goto Totila ad assediare la città nel 542.
Rimane scolpita nella mente del lettore la scena dell’uomo (che Dante ci fa così ben immaginare) che, in terribile solitudine, lega una corda alla trave della propria casa e, dopo aver fatto un nodo scorsoio, mette il cappio sul collo e lascia cadere verso il pavimento il peso del proprio corpo.


