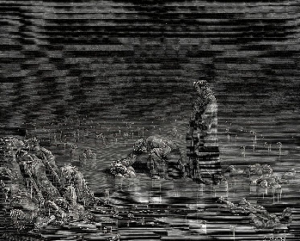Trebisacce-28/08/2023: Rubrica letteraria a cura di Salvatore La Moglie Pubblichiamo qui di seguito l’analisi del canto XXXII dell’Inferno di Dante, del quale Salvatore La Moglie propone un nuovo e originale commento che è diventato un libro pubblicato dalla casa editrice Setteponti di Arezzo. Protagonisti sono i traditori dannati per sempre nel fiume ghiacciato di Cocito.



Rubrica letteraria a cura di Salvatore La Moglie
Pubblichiamo qui di seguito l’analisi del canto XXXII dell’Inferno di Dante, del quale Salvatore La Moglie propone un nuovo e originale commento che è diventato un libro pubblicato dalla casa editrice Setteponti di Arezzo. Protagonisti sono i traditori dannati per sempre nel fiume ghiacciato di Cocito.
Il canto-capitolo XXXII. Siamo sempre nel Regno della Malizia e della Fraudolenza, nel nono cerchio dei traditori. La ghiaccia(ia) del fiume Cocito è divisa in quattro gironi o zone concentriche. Primo girone o zona: Caina (da Caino): i traditori dei congiunti. Sono immersi nel ghiaccio fino al collo, con il viso volto verso il basso. I conti Alberti di Mangona. Sassol Mascheroni. Camicione dei Pazzi. Secondo girone o zona: Antenora (dal principe troiano Antenore, che avrebbe tradito Troia consegnando ai Greci il Palladio): i traditori della patria. Sono immersi nel ghiaccio fino alla testa. Bocca degli Abati, Buoso da Duera, Tesauro dei Beccaria, Gianni dei Soldanieri, Ganellone. Alla fine c’è anche il conte Ugolino della Gherardesca che sta mangiando la testa dell’arcivescovo Ruggieri. Il contrappasso per questi dannati è applicato per analogia: come in vita furono freddi, glaciali traditori, così, nell’Inferno, sono puniti per l’eternità nelle gelide acque del Cocito.
S’io avessi le rime aspre e chiocce, come si converrebbe al tristo buco sovra ‘l qual pontan tutte l’altre rocce, io premerei di mio concetto il suco più penamente; ma perch’io non l’abbo, non sanza tema a dicer mi conduco, chè non è impresa da pigliar a gabbo: descriver fondo a tutto l’universo, né da lingua che chiami mamma o babbo: ma quelle donne aiutino il mio verso ch’aiutaro Anfione a chiuder Tebe, sì che dal fatto il dir non sia diverso.
Oh sovra tutte mal creata plebe che stai nel luogo onde parlare è duro, mei foste state qui pecore o zebe! Come noi fummo giù nel pozzo scuro sotto i piè del gigante assai più bassi, e io mirava ancora all’alto muro, dicere udi’mi: “Guarda come passi; va sì, che tu non calchi con le piante le teste de’ fratei miseri lassi”. Per ch’io mi volsi, e vidimi davante e sotto i piedi un lago che per gelo avea di vetro e non d’acqua sembiante. Non fece al corso suo sì grosso velo di verno la Danoia in Osterlicchi, né Tanaì la sotto il freddo cielo, com’era quivi; che se Tambernicchi vi fosse su caduto, o Pietrapana, non avrìa pur dall’orlo fatto cricchi. E come a gracidar si sta la rana col muso fuor dell’acqua, quando sogna di spigolar sovente la villana; livide, insin là dove appar vergogna eran l’ombre dolenti nella ghiaccia, mettendo i denti in nota di cicogna. Ognuna in giù tenea volta la faccia: da bocca il freddo, e dalli occhi il cor tristo tra lor testimonianza si procaccia.
Quand’io m’ebbi dintorno alquanto visto, volsimi a’ piedi, e vidi due sì stretti, che ‘l pel del capo avìeno insieme misto.
Così inizia il XXXII canto-capitolo che introduce al gelido lago Cocito e alle zone o gironi in cui sono collocati quelli che per Dante sono i peggiori peccatori, la feccia della feccia umana: i traditori dei parenti e della patria o della propria parte politica, con tutte le conseguenze e gli effetti negativi che ne sono derivati (vero e proprio chauchemar, ossessione di Dante quella delle sanguinose e disastrose lotte fratricide tra le opposte fazioni politiche). Per questo, il contrappasso è durissimo e non vi può essere alcun sentimento di pietà per questi uomini-feccia, tutti appartenenti a famiglie potenti e alla classe dirigente, al sistema, all’establishment di allora. E, dunque, nell’introdurre il nono cerchio e la prima zona della ghiacciaia del lago Cocito (la Caina), nelle profondità più abissali dell’Inferno e dell’animo umano, Dante scrive che è davvero cosa molto ardua perché occorrerebbe uno stile, un linguaggio, una narrazione ben adeguata al contenuto, alla materia da trattare: Se io avessi uno stile adeguato alla materia, se usassi (nei miei versi) parole aspre, dure e rauche, stridenti, come sarebbero adatte, adeguate all’orribile pozzo centrale, sul quale si appoggiano tutti gli altri cerchi (e lo stesso universo), io riuscirei ad esprimere meglio, più pienamente la sostanza, l’essenza del mio pensiero, della mia visione; ma poiché non ho queste parole appropriate, non senza timore, mi accingo a descrivere, ad esporre; infatti, non è impresa da poco, da prendere alla leggera descrivere il fondo dell’inferno, (che è poi) il centro della Terra, il fondo dell’universo (secondo il sistema tolemaico), né è possibile farlo usando la lingua, il linguaggio (semplice ed essenziale) del bambino che chiama la mamma o il babbo: (occorre ben altro, per cui) le Muse, che hanno aiutato Anfione a costruire la cinta delle mura di Tebe, aiutino il mio verso (mi vengano in soccorso), in modo che le parole non siano diverse da quel che descrivo, cioè che le parole corrispondano alla realtà dei fatti, (lo stile alla materia, il significante al significato, al contenuto).
Segue un’apostrofe sui peggiori uomini-feccia: O (traditori) massa di dannati più di ogni altro mal nati, sciagurati, spregevoli, voi che siete la feccia dei peccatori che state nel luogo (dell’Inferno) di cui è più difficile, (penoso, terribile) parlare, sarebbe stato meglio se nel mondo foste state pecore o capre (cioè esseri privi di ragione)!
Non appena noi siamo giunti nel pozzo oscuro, in un punto più basso rispetto ai piedi del gigante Anteo, (mentre ancora) guardavo incredulo e stupito l’alto muro del pozzo, ho sentito dirmi (da parte di un dannato): Guarda come metti i passi, stai attento a come cammini; procedi in modo che tu non calpesti, urti con i piedi le teste di due miserabili e sofferenti peccatori, a te fratelli in umanità, cioè pur sempre uomini come te. Per cui, io, mi sono girato e ho visto davanti a me e sotto i miei piedi un lago (il Cocito) che, a causa del gelo, aveva l’aspetto del vetro e non dell’acqua. Né il Danubio in Austria e né il Don (in Russia) durante i freddi mesi invernali, hanno mai fatto una crosta, uno strato di ghiaccio così spesso come quella che ho visto qui; tanto che se vi fosse caduta sopra la montagna di Tambernicchi (in Schiavonia) o quella della Pietra Apuana (l’attuale Pania della Croce), non avrebbe scricchiolato neppure sull’orlo (cioè, non avrebbe subìto neanche una minima incrinatura, tanto è spesso quel ghiaccio del Cocito).
Segue una similitudine: E come la rana sta a gracidare col muso fuori dall’acqua, quando, nel primo periodo estivo (al tempo della mietitura) la contadina spesso sogna di spigolare, di raccogliere le spighe rimaste sul campo; così, allo stesso modo, stanno i sofferenti dannati nel ghiaccio, lividi (per il troppo freddo) fino al viso dove, col rossore, appare, si manifesta la vergogna, battendo i denti come le cicogne il becco, cioè facendo lo stesso rumore. Ognuno di loro teneva il volto verso il basso, in giù (non tanto e non solo per la vergogna, ma forse per consentire alle loro lacrime di gocciolare e di non congelarsi): tra loro il freddo è attestato, si manifesta attraverso la bocca (il battere dei denti) e il dolore, il tormento attraverso gli occhi (col pianto).
Quando, dopo aver osservato alquanto, abbastanza intorno a me, mi sono voltato a guardare verso i miei piedi, ho visto due dannati così vicini tra di loro, quasi una sola cosa, tanto che i loro capelli si confondevano, si mescolavano.
Sono i fratelli fiorentini Napoleone e Alessandro, figli di Alberto degli Alberti, conte di Mangona e padrone dei castelli di Vernio e Cerbaia; i due si uccisero tra di loro, forse nel 1282 o 1286, sia per ragioni politiche, in quanto l’uno ghibellino e l’altro guelfo, ma soprattutto perché Napolene avrebbe avuto solo un decimo del patrimonio paterno mentre gli altri fratelli tutto il resto. Il loro odio mortale dura anche dopo la morte, tanto che anche nelle acque gelide del Cocito si azzuffano e si scambiano cattive parole. Per contrappasso (per contrasto) sono costretti a stare quasi uniti nel ghiaccio e a soffrire ancor di più per via del loro reciproco odio. A rivelare la loro identità sarà Alberto Camicione della casata ghibellina dei Pazzi di Valdarno superiore, che uccise a tradimento il cugino Ubertino per poter essere unico proprietario di alcune fortezze: “Ditemi voi, che sì strignete i petti”, diss’io, “chi siete?”. E quei piegaro i colli; e poi ch’ebber li visi a me eretti, li occhi lor, ch’eran pria pur dentro molli, gocciar su per le labbra, e ‘l gelo strinse le lagrime tra essi e riserrolli. Con legno legno spranga mai non cinse forte così; ond’ei come due becchi cozzaro insieme, tanta ira li vinse. E un ch’avea perduti ambo li orecchi per la freddura, pur col viso in giùe, disse: “Perché cotanto in noi ti specchi? Se vuoi saper chi son cotesti due, la valle onde Bisenzo si dichina, del padre loro Alberto e di lor fue. D’un corpo usciro; e tutta la Caina potrai cercare, e non troverai ombra degna più d’esser fitta in gelatina; non quelli a cui fu rotto il petto e l’ombra con esso un colpo per la man d’Artù: con Focaccia; non questi che m’ingombra col capo sì, ch’i’ non veggio oltre più, e fu nomato Sassol Mascheroni; se tosco se’, ben sai omai chi fu. E per che non mi metti in più sermoni, sappi ch’io fu’ il Camicion de’ Pazzi; e aspetto Carlin che mi scagioni”: Ditemi, chi siete?, voi che state così strettamente abbracciati. E quelli hanno piegato i colli all’indietro (per potermi guardare), e dopo aver alzato gli occhi verso di me, che prima erano umidi, bagnati di lacrime solo dentro, all’interno, hanno cominciato a far scorrere le lacrime fino alle labbra, e il gelo ha congelato le lacrime di entrambi, accecandoli (facendo chiudere i loro occhi, loro che da vivi furono così moralmente ciechi e tanto accecati dall’odio da uccidersi entrambi). Una spranga di ferro non ha mai stretto così forte un legno con un altro legno; per cui, i due dannati quasi uniti tra loro, come due montoni hanno cozzato l’uno contro l’altro, tanta è stata la rabbia (impotente e l’odio eterno) che li ha presi.
E un altro dannato che per colpa del gelo aveva perso entrambi gli orecchi, restando col volto in giù (per evitare che le lacrime si ghiaccino e lo accechino), ha detto: Perché ci fissi tanto (come se ti guardassi in uno specchio)? Se vuoi sapere chi sono questi due, (sappi) che la valle (la Val di Bisenzio) attraversata dal fiume Bisenzio, che scende verso l’Arno, è stata prima del loro padre Alberto e poi di loro due. Sono stati generati dalla stessa madre (la contessa Gualdrada); e tu potrai cercare per tutta la Caina e non troverai un’anima più degna di loro di esser confitta, conficcata in (questa) gelatina (bell’ironia culinaria!…); (certo) non l’anima di Mordrec (o Mordret, nipote di re Artù, che aveva tentato di ucciderlo per il trono) al quale (Artù), con un solo colpo di lancia, gli ha ferito il petto e tolto l’ombra del corpo; non Focaccia (Vanni dei Cancellieri detto Focaccia, della nota famiglia pistoiese di parte Bianca; uccise a tradimento il cugino Detto dei Cancellieri); e neanche questo (che mi è vicino) che tanto mi impedisce, con la sua testa, di vedere più avanti, più oltre, e si chiama Sassol Mascheroni (della nobile famiglia fiorentina dei Toschi; uccise a tradimento un giovanissimo cugino per ereditare il grande patrimonio di uno zio; fu, però, scoperto e orribilmente punito dalle autorità); se sei toscano, sai benissimo chi sia costui (che fior fiore di assassino…). E affinchè tu la smetta di seccarmi facendomi altre domande (oppure: non mi infastidisca con altre parole, non mi faccia parlare ancora…), sappi che io sono stato (sulla Terra) Camicione dei Pazzi; e aspetto che Carlino mi scagioni (cioè, avendo commesso Carlino una colpa più grave, farà così apparire la mia meno grave: Carlino dei Pazzi di Valdarno, suo cugino, aveva tradito i suoi compagni di partito, i Bianchi, consegnando, per denaro, nel 1302, ai Neri, il castello di Piantravigne; Camicione dice che non vede l’ora che Carlino venga precipitato nell’Antenora, perché la pena dei traditori della patria o del partito politico è ancora più grave della sua).
Dante dice poi di aver visto tantissimi altri visi lividi e paonazzi per il gelo e, mentre camminano, gli accade di colpire forte col piede la testa di un dannato (è Bocca degli Abati), col quale viene a plebeo e volgare scontro verbale, simile a quello tra maestro Adamo e Sinone, per la cui affascinata attenzione Virgilio lo aveva severamente richiamato, redarguito dicendogli che certi spettacoli plebei non sono cose da animo nobile quale lui era e che, pertanto, mai più avrebbe dovuto indulgere, soffermare la sua attenzione su zuffe, alterchi di bassa lega come quella a cui aveva assistito. Adesso, però, Virgilio sembra aver dimenticato quel rimprovero che aveva fatto arrossire Dante e concede al discepolo di scendere a plebea diatriba, zuffa con il dannato. La verità è che Dante è il grande demiurgo della Divina Commedia e Virgilio non altro che il suo alter ego e, quindi, adesso lo mostra opportunamente come un severo padre e pedagogo pronto a dare la lezione morale e di vita con tono così deciso da far arrossire e poi come il paterno maestro che concede all’allievo qualche trasgressione, qualche mancanza, qualche pecca, magari anche di avere un volgare e violento scontro verbale e anzi fisico, fino al venire alle mani, con un dannato che si rivela e conferma quell’uomo-feccia che è stato sul mondo. Alla fine, il malvagio e vendicativo Bocca degli Abati fa a Dante altri nomi di dannati di cui potrà riferire ai vivi una volta che ritornerà sulla Terra (come dire: qui non ci sono solo io, ma tanti altri mal nati…). Il canto-capitolo si chiude con uno spettacolo, una scena raccapricciante, da romanzo-film dell’orrore: una scena che registra un atto di cannibalismo: un dannato (il conte Ugolino della Gherardesca) rode la testa di un altro (l’arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini), la mangia a pezzetti ed è cosa che farà per l’eternità: Dante, dopo aver spiegato, con una similitudine, il terrificante spettacolo, invita il dannato che rode la testa dell’altro a dire chi è e a raccontare la sua storia spiegando le ragioni più profonde di un odio così grande da indurlo a mangiare pezzo per pezzo la testa del suo vicino di pena e, se lo farà, gli promette che ne recherà memoria nel mondo dei vivi: Poscia vid’io mille visi cagnazzi fatti per freddo; onde mi vien riprezzo, e verrà sempre, de’ gelati guazzi. E mentre ch’andavamo inver lo mezzo al quale ogni gravezza si rauna; se voler fu o destino o fortuna non so; ma, passeggiando tra le teste, forte percossi il piè nel viso ad una. Piangendo mi sgridò: “Perché mi peste? Se tu non vieni a crescer la vendetta di Montaperti, perché mi moleste?”. E io: “Maestro mio, or qui m’aspetta, sì ch’io esca d’un dubbio per costui; poi mi farai, quantunque vorrai, fretta”. Lo duca stette, e io dissi a colui che bestemmiava duramente ancora: “Qual se’ tu che così rampogni altrui?”.
“Or tu chi se’ che vai per l’Antenora percotendo” rispuose “altrui le gote, sì che, se fossi vivo, troppo fora?”.
“Vivo son io, e caro esser ti pote” fu mia risposta, “se dimandi fama, ch’io metta il nome tuo tra l’altre note”.
Ed elli a me: “Del contrario ho io brama; lèvati quinci e non mi dar più lagna, chè mal sai lusingar per questa lama!”.
Allor lo presi per la cuticagna, e dissi: “El converrà che tu ti nomi, o che capel qui su non ti rimagna”.
Ond’elli a me: “Perché tu mi dischiomi, né ti dirò ch’io sia, né mosterrolti, se mille fiate in sul capo mi tomi”.
Io avea già i capelli in mano avvolti, e tratti li n’avea più d’una ciocca, latrando lui con li occhi in giù raccolti, quando un altro gridò: Che hai tu, Bocca? Non ti basta sonar con le mascelle, se tu non latri? Qual diavol ti tocca?”.
“Omai” diss’io “non vo’ che tu favelle, malvagio traditor; ch’alla tua onta io porterò di te vere novelle”.
“Va via” rispuose, “e ciò che tu vuoi conta; ma non tacer, se tu di qua entro eschi, di quel ch’ebbe or così la lingua pronta. El piange qui l’argento de’ Franceschi: ‘Io vidi’ potrai dir ‘quel da Duera la dove i peccatori stanno freschi’. Se fossi domandato ‘Altri chi v’era?’, tu hai da lato quel di Beccheria di cui segò Fiorenza la gorgiera. Gianni de’ Soldanier credo che sia più là con Ganellone e Tebaldello, ch’aprì Faenza quando si dormìa”.
Noi eravam partiti già da ello, ch’io vidi due ghiacciati in una buca, sì che l’un capo all’altro era cappello; e come il pan per fame si manduca, così ‘l sovran li denti all’altro pose là’ ve ‘l cervel s’aggiugne con la nuca: non altrimenti Tideo si rose le tempie a Menalippo per disdegno, che quei faceva il teschio e l’altre cose.
“O tu mostri per sì bestial segno odio sovra colui che tu ti mangi, dimmi ‘l perché” diss’io, “per tal convegno, che se tu a ragion di lui ti piangi, sappiendo chi voi siete e la sua pecca, nel mondo suso ancora io te ne cangi, se quella con ch’io parlo non si secca”: Poi (proseguendo e trovandomi nella seconda zona, l’Antenora, dove sono puniti i traditori della patria o del partito politico di appartenenza) ho visto tantissimi altri volti diventati lividi, paonazzi (per il gelo); per cui (per la cui visione) rabbrividisco, mi viene e mi verrà sempre un brivido di orrore al pensiero degli (di quegli) stagni (o acquitrini) gelati (è un rabbrividire sia fisico che interiore pensare che ogni anima è imprigionata in una sorta di pozzetto gelato, fatto a bella posta per essa in eterno). E mentre noi procediamo verso il centro della Terra, del mondo verso cui cadono, sono attratti tutti i corpi pesanti per via della legge di gravitazione universale (ma anche tutte le cose moralmente abiette dell’uomo-feccia), io ho tremato nel freddo, nella frescura, nel gelo eterno di quel cerchio; non so se sia stato, se sia accaduto per mia volontà, per volontà divina o per puro caso; ma, camminando in mezzo a quelle teste (dei dannati) ho colpito fortemente col piede il volto di una di esse (gli ha assestato un forte calcio!). (L’anima) piangendo, mi ha sgridato, ha gridato forte, con tono di rimprovero: Perché mi colpisci (calpesti, pesti)? Se tu non sei venuto qui per far aumentare, per rendere più pesante, più dura la punizione divina per il mio tradimento di Montaperti, (allora) perché mi infastidisci, mi tormenti?
Dante è preso da un atroce sospetto: forse il dannato che protesta è proprio colui il quale, con il suo terribile e imperdonabile tradimento da voltagabbana che vuol salire sul carro del vincitore, ha provocato la sconfitta dei Bianchi nella battiglia di Montaperti (4 settembre 1260) a opera dei ghibellini guidati da Farinata degli Uberti: pare che il dannato abbia tagliato la mano dell’alfiere Jacopo Nacca de Pazzi, che portava l’insegna della cavalleria di Firenze, provocando, in tal modo, lo sbandamento delle truppe dei guelfi Bianchi. Insomma, il dannato si è smascherato da sé e Dante, fingendo di avere un forte dubbio, chiede a Virgilio (che acconsente perché così dev’essere, anche perché, aldilà della finzione letteraria, Dante si presenta e si sente, nel suo viaggio-missione, strumento della Giustizia divina), chiede di aspettarlo perché deve chiarirsi in merito a un suo dubbio: Maestro mio, (ti prego) aspettami qui, finchè non chiarisco, non sciolgo un dubbio in merito a costui; poi mi potrai far affrettare per quanto vorrai. Virgilio si è fermato, e io ho detto al dannato che ancora continuava a imprecare fortemente (e con rabbia): Chi sei tu che così (aspramente) mi rimproveri, mi attacchi?
Inizia il botta-e-risposta alquanto plebeo e volgare, come in una sorta di regolamento di conti in cui il dannato deve ben spiccare con la sua terribile colpa (che tante conseguenze ha poi avuto per la vita sociale e politica dei fiorentini), per cui il risentito dannato replica così: Piuttosto, chi sei tu che cammini per l’Antenora colpendo, percuotendo i volti degli altri (in questo caso: il mio), tanto chè, se anche tu fossi vivo, in carne ed ossa, il tuo calcio sarebbe stato troppo forte, ma è preferibile tradurre così: se io fossi stato uomo vivo, non avrei sopportato, non avrei mandato giù una tale offesa e mi sarei vendicato, te l’avrei fatta pagare (confermando, così, la sua natura malvagia e il suo istinto violento).
Dante ribatte così: Io (invece) sono davvero vivo e ti può essere cosa gradita, se desideri acquistare fama, se tu chiedi che sia lasciata fama di te sulla Terra, che io metta, aggiunga il tuo nome tra le (tante) cose annotate, notate, registrate (nella mia narrazione, nel mio poema-libro-della-memoria: e sarebbe, in verità, una annotazione infamante, diretta a farlo risaltare come un infame e, quindi, togliergli ogni pur minimo buon ricordo tra i contemporanei e i posteri: infame per sempre! Si tratta di una finta captatio benevolentiae e, infatti, il dannato si nega decisamente).
Il dannato non ne vuol sapere di fama e di memoria eterna: essere ricordato è la vera infamia!: Io ho desiderio del contrario, cioè di oblio, di essere dimenticato (per sempre, tanto è consapevole della sua grave colpa); e quindi levati di torno, allontanati, vattene via di qui e non infastidirmi più; poiché le tue lusinghe non mi servono, valgono ben poco in questa zona, bassura, valle del Cocito (dove le fredde acque ristagnano). Il dannato ha capito che Dante ironizza, che è beffardo in merito alla sua presunta fama presso i vivi e per questo gli dà quella risposta stizzita, come a voler dire: chi vuoi prendere in giro!.
Di fronte a tanta sfrontatezza e viltà del dannato che non vuol rivelarsi e vorrebbe occultare in eterno la sua grave colpa in un eterno oblio, Dante – preso da un sentimento di forte ira e sdegno per quell’uomo-feccia – perde il controllo di sé e scende al suo basso livello, afferrandolo per i capelli: Allora, l’ho afferrato per i capelli della collottola, per la chioma della nuca e gli ho detto: Ti conviene che tu mi dica il tuo nome, altrimenti non ti resterà un capello sulla testa, ti strapperò tutti i capelli!
Allora il dannato (chiuso nella sua resistenza a smascherarsi e a confessare apertamente le sue responsabilità) gli ribatte con tono da far andare in bestia un santo come Dante: Se anche tu mi strappi (tutti) i capelli, non ti dirò (mai) chi sono né (mai) te lo rivelerò, te lo farò conoscere, se pure mi piombassi addosso mille volte sulla testa con tutto il tuo peso.
La sfacciataggine e la vigliaccheria del dannato fa uscire Dante da sé, lo fa andare in bestia: uno così non gli è mai capitato! E commentano bene i già citati Fallani e Zennaro quando scrivono che: …contro la viltà del traditore e quel suo linguaggio quasi da vernacolo Dante insorge, in maniera inconsueta, lasciando la discussione e passando ai fatti, secondo una dialettica spicciola, che non può essere diversa con simili gente. A costo di abbassarsi a quel livello di abiezione, con baldanza vendicativa conduce il tema della lotta con l’avversario nel clima furibondo e disumano; lo afferra per i capelli… E anche Attilio Momigliano, nel commentare l’episodio, ha scritto bene che: La violenza si accompagna con la maestà del giustiziere: chi colpisce è il ministro della giustizia [divina], il vindice della rettitudine; e quanto più Bocca è simile ad una belva, tanto più forte risplende l’umanità di Dante. E questo perché Dante è troppo umano, vuole sconfiggere la disumanità degli uomini-feccia e, pertanto, anche a costo di apparire disumano a sua volta, assume, in certi casi, l’aspetto del cinico e del disumano comportandosi, per es., come ha fatto con Bocca e come farà con un altro dannato, per il quale, non aver aperto i sofferenti occhi per dargli un sollievo, è stata una cortesia l’esser stato un villano…
Dunque, Dante, perde le staffe, e passa all’attacco fisico dopo quello verbale: Io avevo già i suoi capelli (ben) avvolti nelle dita della mia mano e gliene ho strappati più di una ciocca, e si è messo a urlare come un cane, con gli occhi rivolti in basso (per l’effetto doloroso dello strappo), quando un altro dannato ha urlato: Che cos’hai, Bocca? Non ti basta far rumore con le mascelle (per il troppo freddo), ma devi anche urlare come un cane? Che diavolo ti prende? Che diavolo hai?
E Dante, arrabbiatissimo: Ormai non voglio che tu più parli, malvagio traditore; che per far aumentare la tua infamia io, una volta nel mondo, porterò di te, sul tuo conto, notizie ben certe, ben precise.
L’infame resta sempre tale e replica così a Dante: Vattene via da qui, e racconta pure quello che vuoi; ma non tacere, se pure mai uscirai da qui, di colui che, adesso, ha avuto la lingua così pronta a parlare, a fare il mio nome. Egli è qui punito, paga e soffre per il denaro preso dai Francesi per il suo tradimento. Potrai dire un giorno: Io ho visto Buoso da Duera (o Dovera o Dovara, signore di Cremona che tradì Manfredi nel 1265 prendendo il denaro del re francese Carlo d’Angiò che, così, non trovò alcuna resistenza in Lombardia), nel nono cerchio dove i peccatori stanno freschi (un’autoironia davvero azzeccata! I dannati stanno freschi, come popolarmente si dice, per dire che stanno molto male, confitti come sono nel ghiaccio per l’eternità…). E se ti chiedessero: Chi c’era ancora in quel posto? (Ebbene sappi che) tu hai al tuo fianco quel (traditore di) Tesauro da Beccheria (di Pavia, che fu ucciso dai suoi compagni guelfi fiorentini, perché sicuri del suo tradimento per favorire i ghibellini) al quale Firenze ha tagliato la gola, cioè ha punito con la decapitazione. Più in là, credo ci siano Gianni dei Soldanieri (fiorentino e ghibellino che tradì il suo partito per sete di potere, nel 1266) insieme a Gano di Maganza (Ganellone, traditore di Carlo Magno e dei suoi paladini sconfitti a Roncisvalle) e Tebaldello dei Zambrasi, di Faenza, che ha tradito consegnando la città ai nemici bolognesi (guelfi) aprendone le porte alle prime luci dell’alba, quando la gente dormiva (il 13 novembre 1280).
Dante, infine, ci introduce al cannibalismo del conte Ugolino, una vera e propria scena da film dell’orrore che vuol dimostrare a cosa può condurre l’odio tra gli uomini: Noi ci siamo appena allontanati da lui (da Bocca), quando ho visto (mi è capitato di vedere) due dannati confitti nella stessa buca, in modo che la testa dell’uno sovrastava, faceva da cappello a quella dell’altro, cioè stava sulla testa dell’altro; e come il pane si mangia per fame, così, allo stesso modo quello che stava sopra metteva i denti, cioè rodeva (continuamente, perché l’atto del conte Ugolino di addentare è eterno) nella parte dove il cervello si congiunge con il midollo spinale, la colonna vertebrale, cioè nella nuca (nella medicina medievale, la nuca era sinonimo di midollo spinale): non diversamente Tideo (re di Caledonia e uno dei sette re che assediarono Tebe; fu ucciso da Menalippo e questi da lui, che, prima di spegnersi, volle la testa mozzata di Menalippo e la azzannò più volte con estrema rabbia e ferocia) aveva azzannato e mangiato la testa di Menalippo per odio rabbioso, che quel dannato faceva con la testa e le parti carnose, la pelle, il cervello (quel cervello con cui aveva architettato l’orribile vendetta contro Ugolino e soprattutto contro i suoi figli e nipoti, fanciulli innocenti costretti a morire atrocemente per fame).
Dante gli dice: O tu che mostri, con tale atto disumano, bestiale, tanto odio verso la persona di cui rodi, mangi la testa, dimmi, raccontami perché, con questo patto, accordo, impegno: se tu hai le tue ragioni, i tuoi motivi per lamentarti di lui e odiarlo (così terribilmente), una volta conosciuto, saputo chi voi due siete e la sua colpa (Ugolino sembra già non averne alcuna…), io potrei ripagarti, ricambiarti (per il tuo racconto) una volta tornato sulla Terra (facendo conoscere a tutto il mondo e per l’eternità le tue ragioni e, quindi, rendendoti giustizia del torto subìto da quell’uomo), se la mia lingua, la mia parola non si secca, non si paralizza (altri intendono: se io non muoia prima del tempo; ma è certamente preferibile pensare, come pure tanti commentatori osservano, che Dante abbia voluto riferirsi al suo verso immortale: fortemente consapevole che la poesia, la parola poetica, letteraria sia capace di immortalare, di rendere eterno ciò di cui il poeta scrive, e fortemente cosciente, anche, del fatto che la sua opera sarà capace di sfidare il tempo, di andare oltre la precarietà della vita umana, egli propone al conte Ugolino (con molta captatio benevolentiae) uno scambio: il racconto della tua storia (che a me serve per il mio romanzo) in cambio della vendetta, della giustizia che la mia opera immortale ti renderà nel mondo. E queste parole dimostrano anche che Dante aveva consapevolezza moderna in merito al fatto che la letteratura (oltre ad eternare uomini e cose) sia una particolare forma e modalità di comunicazione di massa e, nello stesso tempo, consapevolezza in merito a uno dei compiti della letteratura cioè quello di demistificare e smascherare le falsità, le menzogne e ristabilire la verità, facendola trionfare. E, dunque, la letteratura come Tribunale Morale.
Ugolino mostra di avere fiducia in Dante e coglie la palla al balzo: sa che un’occasione del genere non gli si ripresenterà mai più e, così, lascia per un po’ il fiero pasto e si mette a raccontare di cosa possa essere capace l’uomo-feccia su questa Terra, sull’aiuola che ci fa tanto feroci. E intanto noi, così commossi dal suo racconto, dimentichiamo che anche lui è un dannato. Proprio come abbiamo fatto con Francesca da Rimini, Farinata, Pier delle Vigne e Ulisse.