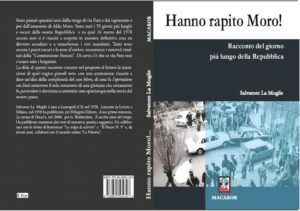Amendolara-21/04/2018: E’ uscito il libro “Hanno rapito Moro!” di Salvatore La Moglie

INTRODUZIONE
Questo breve lavoro (che, in verità, non è che la minima parte di un progetto ben più ampio) vuol essere il ricordo della tragedia vissuta da Aldo Moro e da un intero paese nel racconto di un solo giorno. Dunque, sottoforma di diario, si vuol proporre al lettore la narrazione di quel tragico giovedì nero della Repubblica, ovvero di quello che successe il 16 marzo del 1978, con una sorta di scommessa: riuscire a dare un’idea della complessità del caso Moro, di cosa fu l’operazione via Fani a un signore anziano che i 55 giorni visse e a un ra- gazzo che non sa neppure chi è Aldo Moro attraverso il solo resoconto di una giornata che certamente fu particolare e de- stinata a costituire uno spartiacque nella storia del nostro paese. Ebbene, crediamo di esserci riusciti. Comunque, il let- tore lo potrà constatare da sè.
Quella di Moro, presidente della Democrazia Cristiana, che il 16 marzo del 1978 stava per recarsi in Parlamento per votare il nuovo ministero Andreotti che vedeva per la prima volta, dopo trent’anni, la presenza del PCI nell’area del go- verno, anche se solo nella maggioranza parlamentare, fu una vicenda così importante che può essere definita non solo un gigantesco giallo ma una vera e propria metafora del nostro paese, del suo destino politico.
Sono passati quarant’anni dalla strage di via Fani e dal rapimento e poi dall’assassinio di Aldo Moro. Sembra ieri e sembra un secolo fa. Sono stati i 55 giorni più lunghi e oscuri della nostra Repubblica (che, come ha scritto il giudice Fer- dinando Imposimato, hanno cambiato l’Italia) e su quel 16 marzo dell’indimenticabile 1978 ancora non si è riusciti a scoprire in maniera definitiva cosa sia davvero accaduto, o meglio si dovrebbe dire cosa è stato fatto accadere da qual-
cuno, e tuttora non è stato possibile smascherare i veri man- danti. Certo, oggi, dopo più di una rivelazione sullo zampi- no dei servizi segreti stranieri e nostrani (i cui vertici, all’epoca, erano quasi tutti iscritti alla P2 di Licio Gelli), sulla presenza in via Fani di uomini della ‘ndrangheta calabrese (Antonio Nirta e Giustino De Vuono) e dopo i più recenti risultati della nuova Commissione d’inchiesta sul caso Moro (guidata da politici seri come Giuseppe Fioroni e Gero Grassi, il quale ho avuto la fortuna di conoscere in uno dei suoi tour sul caso Moro) continuare a credere alle convergenti verità dei brigatisti e di Cossiga (l’allora ministro degli Inter- ni e, qualche anno più tardi, Capo dello Stato) appare, fran- camente, sempre più difficile e impossibile. Potremmo forse concludere con Antonio Ferrari, autore del libro Il segreto (Chiarelettere, 2017) che l’affare Moro fu una grande porcheria internazionale.
Sono stati tanti gli anni in cui siamo stati costretti a fare dietrologia, a pensare a cosa c’è stato dietro, a meno di non vo- ler accettare la verità di Stato (la verità dicibile…), quella di Cossiga, soprattutto, e quella omologa dei terroristi Moretti, Morucci e Faranda (si veda il famoso e soprattutto fumoso Memoriale Morucci-Faranda messo in piedi con l’aiuto del giornalista del Popolo Remigio Cavedon e dato in pasto agli italiani come la verità rivelata…) secondo cui via Fani fu un’operazione tutta brigatista, di brigatisti puri e duri che sognavano la Rivoluzione comunista, ecc. ecc.
La verità o comunque qualcosa che è vicina ad essa è che in via Fani, il 16 marzo, c’erano almeno venti killer, di cui alcuni della mafia calabrese (espertissimi nell’arte di uccidere i propri simili con spietatezza, come Giustino De Vuono), uomini dei servizi segreti, gladiatori (quelli, cioè, della struttu- ra segreta denominata Gladio) non solo nostrani, e anche al- cuni brigatisti, messi lì a fare da copertura con la sigla, con il
marchio Brigate Rosse, marchio che i terroristi sotto processo a Torino, cioè i Curcio e i Franceschini, confermarono dal carcere, avallando in tal modo un atroce e infame massacro, un infame delitto politico. In un bel libro del 1984, Operazio- ne Moro, Giuseppe Zupo e Vincenzo Marini Recchia, scrive- vano, nelle pagine iniziali, che: “A via Fani, il grosso del massacro l’ha fatto la mafia. Ma nessuno deve saperlo”.
La parola pacata, razionale, lucida, chiara e decisa di Mo- ro che, verso la fine, si espresse sempre più in un urlo dispe- rato e impotente fino al rassegnato tutto è inutile quando non si vuole aprire la porta, la sua parola non la si volle ascoltare, la si bollò subito, cioè già prima che giungesse un suo scritto dal carcere, come moralmente a lui non ascrivibile, come, cioè, priva di ogni valore e, praticamente, quella di un vile o di un paz- zo da interdire. E, quindi, per evitare la trattativa, screditare Moro era l’operazione-montatura che occorreva mettere in piedi e che fu portata avanti, di conserva (anche questa volta in strana quanto perfetta convergenza parallela) dalla classe po- litica e dalla maggiorparte dei mezzi di comunicazione, tutti attestati sulla inerte e inconcludente linea della fermezza che condannava Moro a morte certa.
Il leader democristiano non fu nè vile nè tantomeno paz- zo e neppure affetto dalla sindrome di Stoccolma, come si ripe- teva allora da più parti, cioè in piena e incomprensibile sin- tonia-empatia collaborativa con i terroristi fino a farne pro- prie le richieste e farsene portavoce. I vili e i pazzi erano ben altri… La verità è che il Moro del carcere non solo si è con- fermato l’uomo politico più lucido d’Italia ma è probabil- mente il Moro più autentico, più vero e più umano che si sia conosciuto fino allora e quello che, di fronte alla terribile morte incombente, ha deciso di dire la verità, magari la sua verità, e di dirla fino in fondo, quasi come a voler lasciare un testamento politico, morale e umano agli italiani.
La posta in gioco, in quel lontano e terribile 1978, era al- ta, anzi altissima, tanto che Giovanni Spadolini, storico e senatore repubblicano, definì, in quei tristissimi giorni, colpo di Stato freddo quello di via Fani e fu tra i primi a dire che, dopo quello che è accaduto, nulla sarà più come prima del 16 marzo.
Certamente il corpo di Moro rannicchiato nel bagagliaio della Renault 4 rosso-amaranto sembra l’immagine dello Sti- vale, è, insomma, una metafora: in quella Renault c’è l’Italia prigioniera e vittima di un pesante ricatto politico di altissi- mo livello, tanto da scegliere come luogo una via – via Cae- tani – a due passi dalle sedi della DC e del PCI, e non una mera beffarda simbologia scaturita dalla fervida immagina- zione dei brigatisti. Il leader democristiano è un cadavere eccel- lente che deve costituire un monito per chiunque voglia di- sobbedire e opporsi alla ferrea logica di Yalta, alla logica dei Bloc- chi contrapposti che Moro cercò coraggiosamente di superare con anticipo di anni, volendo difendere in tal modo la no- stra dignità e sovranità nazionale, che i nostri alleati preferi- vano limitata e sottoposta a controllo. Insomma, la DC di Moro (che in quegli anni viveva una profonda crisi) e Moro stesso apparivano sempre meno come il partito americano che garantisce l’Alleato USA ora e sempre in merito al problema del comunismo e della superfedeltà atlantica, e anche se il PCI di Berlinguer (l’anomalia italiana…) mostrava sempre più di essere affidabile e legittimabile come partito democratico e forza di governo, per gli alleati americani ed europei (so- prattutto inglesi, tedeschi e francesi) non bastava e, pertan- to, bisognava fermare Moro. E qualcuno lo fermò, per sempre. E dunque: missione compiuta! L’ennesima operazione Gattopardo era riuscita, il caso italiano era risolto una volta per tutte e il PCI si ritrovò, dopo neppure un anno, nuovamente ricaccia- to all’opposizione. Gli anni della solidarietà e dell’unità na-
zionale si sarebbero chiusi nel 1979, poi si sarebbe ritornato all’Italia di prima cancellando con un violento colpo di spu- gna la possibilità di un’Italia diversa che era nella visione del lungimirante Moro, il quale, in verità, era nel mirino da anni per la sua politica di apertura a sinistra. Lo si voleva eliminare già ai tempi del centrosinistra, a metà degli anni ’60, preci- samente nel 1964, secondo quanto rivelò Mino Pecorelli sul finire del 1967 nel suo periodico Il Nuovo Mondo d’Oggi. Non solo, ma, dieci anni dopo, Moro fu salvato dalla strage del treno Italicus del 4 agosto del 1974, sul quale era salito: fu fatto scendere da alcuni uomini dei nostri servizi col pretesto di firmare importanti documenti e gli fu evitata una morte violentissima. Qualcuno, evidentemente, volle salvarlo ma, soprattutto, lanciargli un avvertimento: se noi vogliamo, possia- mo eliminarti quando vogliamo. Questo qualcuno erano gli stessi uomini degli eterni servizi segreti deviati e paralleli, già esperti in più di una strage diretta a bloccare la situazione politica e a far arretrare di decenni la sinistra, i sindacati e il movimen- to dei lavoratori. Erano gli uomini, i gladiatori dei golpes mi- nacciati per realizzare le ennesime operazioni di blindatura del Sistema nell’ambito della ferrea logica di Yalta.
Ma perché ancora oggi, dopo 40 anni e dopo i conside- revoli risultati della seconda Commissione Moro si pensa sempre in termini di chi c’era dietro? Innanzitutto, perché tut- tora – come per tante altre orribili stragi e delitti politici del nostro paese – non esiste una verità definitiva e soddisfa- cente sull’affare Moro. Tante cose sono ancora destinate a re- stare misteri e/o segreti, come per es., le borse di Moro, in alcune delle quali il leader democristiano portava documenti riservati, e, soprattutto, il Memoriale (che Miguel Gotor ha giustamente definito della Repubblica) che, a noi mortali, è stato dato di conoscere solo in forma censurata. Tanti sono i puntini di sospensione, gli omissis (operati da chi?) nella
narrazione di Moro, il quale chissà cosa aveva scritto a futu- ra memoria degli smemorati italiani… Non lo sapremo for- se mai, ma c’è chi ha letto, c’è chi ha censurato, c’è chi ha avuto tra le mani e c’è chi sa dove è custodito il testo com- pleto del Memoriale. E poi ci sono tanti altri misteri destinati probabilmente a restare tali, come i veri prigionieri e le vere prigioni in cui fu tenuto Moro; il ruolo dell’inquietante bar Olivetti della scena della strage (frequentato da mafiosi e da personaggi da servizio segreto, con i relativi illeciti traffici); il ruolo del Vaticano come il ruolo che svolse, durante il se- questro del leader democristiano, l’esperto americano nonché già uomo di fiducia di Henry Kissinger, Steve Pieczenik, lo psichiatra-agente-della-Cia che collaborò con il comitato di cri- si, o dei tecnici che dir si voglia, messo in piedi da Cossiga al Viminale per affrontare la cosiddetta sfida delle BR allo Stato e che, per sua stessa ammissione, si adoperò affinchè i brigati- sti uccidessero il prigioniero. Importante, ha riferito più di una volta il terroristologo americano, non era la vita di Moro perché nessun uomo politico è indispensabile alla sopravvi- venza dello Stato-nazione, ma la stabilizzazione dell’Italia. E, dunque, fingere di destabilizzare il nostro paese ma, nei fatti, operare in modo da stabilizzarlo in senso conservatore, in direzione dello status quo e, quindi, della ferrea logica di Yal- ta: destabilizzare per stabilizzare…
Si pensi, poi, che una fonte palestinese, proveniente da Beirut, datata 18 febbraio 1978, aveva fatto sapere che, in Italia, era in preparazione un grave attentato. Informazione che il ministero degli Interni, guidato da Cossiga, e i vertici dei nostri servizi segreti finsero di non aver visto, letto e udito. Più di un servizio e più di un paese sapeva che in Italia sarebbe accaduto qualcosa di grave contro un’alta personali- tà politica (cioè Moro…), ma non si fece nulla per protegge- re questa personalità: la si lasciò scoperta e la scorta (senza
auto blindate!…) mandata al macello. Tante furono le omis- sioni, le deficienze e anche le colpevoli complicità di molti ad altissimo livello politico e istituzionale (la magistratura, le forze dell’ordine, i vertici politici, ecc.) e queste sono cose che la Commissione Fioroni ha fatto emergere come una sorta di atto d’accusa, ma che anche allora apparivano così lampanti ed evidenti ma la vulgata era che le nostre forze dell’ordine, di fronte al mostruoso ed efficientissimo eserci- to brigatista (quattro gatti…) erano inefficienti, che i nostri ser- vizi erano stati smantellati dalla solita sinistra che punta il di- to contro i suoi vertici deviati e che le BR avevano infiltrati e complici un po’ dappertutto e anche in ministeri-chiave per non parlare dei fiancheggiatori e simpatizzanti della Nuova Sini- stra (la famosa aerea contigua o di consenso, il famoso brodo di coltura…) che, dunque, diventava facile da criminalizzare, perseguire e reprimere al fine di smantellarla una volta per tutte. In verità, ben altri e ad altissimo livello, erano i fian- cheggiatori e i simpatizzanti del partito armato… E, pertanto, alle conclusioni dietrologiche, complottistiche o se si vuole alla conclusione che il caso Moro non fu un evento rivoluzionario operato per attuare la giustizia proletaria attraverso il processo a una classe politica di cui Moro era ritenuto il massimo rappresentante e il massimo responsabile, è pervenuta la Commissione, la cui relazione finale di Fioroni (dicembre 2017) afferma che il lavoro non è esaustivo ma che si sono fatti significativi passi in direzione della verità, cioè di quella indicibile per il Paese. E, dunque, la verità sull’affaire non è totale, è in parte avvolta nel mistero e si potrebbe dire con Pasolini che: Io so, ma non ho [tutte] le prove…
Le domande, i dubbi e i sospetti sono, dunque, tuttora tanti ma la domanda delle domande è: chi ha veramente vo- luto i 55 giorni, cioè fare un finto processo a Moro e alla DC e tenere in scacco e sotto ricatto un’intera nazione? Quando
il prigioniero scriveva, in codice, di trovarsi sotto un dominio pieno e incontrollato, voleva dire non quello dei brigatisti, ma di chi stava loro dietro, di chi li lasciava fare, di chi li usava come pedine e utili idioti e, dunque, Moro cercava di dirci che lui era tenuto nell’appartamento di un grande complesso di abi- tazioni che sfuggiva al controllo delle forze dell’ordine, pro- prio perché godeva, di fatto, dell’extraterritorialità, dell’extragiurisdizionalità o che, comunque, era coperto dai servizi segreti piduisti.
In verità, una domanda da porsi è anche questa: perché Moro non è stato ucciso in via Fani, insieme ai cinque uomi- ni della scorta? Evidentemente, chi progettò la strage e poi i 55 giorni di prigionia aveva come obiettivo principale non so- lo di umiliare e distruggere politicamente e poi fisicamente il futuro Presidente della Repubblica ma, allo stesso tempo, quello di tenere prigioniera e sotto pesantissimo ricatto non solo un’intera classe politica (non molto amata dalla mag- giorparte degli italiani) ma soprattutto un intero Paese.
I brigatisti non erano mere schegge impazzite, come si diceva allora, ma dietro c’erano quelli che a me piace definire brigati- sti senza mitra o con altre armi, questi più pericolosi dei primi in quanto rappresentavano il livello politico-istituzionale- lobbistico più occulto dell’attacco alla Repubblica democra- tica nata dalla Resistenza. Di questo livello superiore, occulto e insospettabile del brigatismo (quello in doppiopetto…), fatto di uomini politici ultraconservatori ma anche di gruppi di potere reazionari parlò, nel mese di aprile del 1978, sul pe- riodico Il Mensile, Ruggero Orfei, intellettuale anomalo della sinistra democristiana. Solo pochissimi giornali (l’Avanti! più ampiamente) ripresero la sua impressionante e inquietante analisi. Dunque, Orfei, parlava delle BR e del partito armato in genere, cioè quello fatto di tante sigle, come di una struttura di servizio agli ordini di un uomo politico o di un gruppo di poli-
tici, o anche di un gruppo di potere, una specie di potentis- sima lobby, una sorta di superpartito, che aveva come disegno quello di cambiare le regole del gioco, cambiare il paese in senso reazionario, anticomunista, antisindacale e antipopola- re. Egli parlava di gruppi di potere che si sentivano minacciati nei loro interessi, privilegi e “principi” politici e, quindi, dell’esistenza di un “partito eversivo” legale che si serve del “partito eversivo armato” che esegue gli ordini ricevuti. Il pensiero non può che andare alla Loggia P2 di Licio Gelli e al suo famigera- to Piano di rinascita nazionale.
Chi come Raniero La Valle scrisse allora, sulle colonne di Paese Sera, che in via Fani era avvenuta una Caporetto e, in- somma, una vergogna nazionale che non poteva essere lavata con la via facile di un’assurda e inerte linea della fermezza, non si sbagliava perchè non era certo con il sangue di Moro che si sarebbe salvato uno Stato per il quale la DC al potere da più di trent’anni non aveva mai avuto il senso, se non il senso del potere fine a se stesso, tanto da averlo occupato e gestito an- che con tanti scandali, malaffare e normale convivenza con le mafie. Durante il caso Moro la DC scoprì, improvvisamen- te, il senso dello Stato e delle sue istituzioni e decise, già il 16 marzo, che questo Stato (così, giustamente, lo definiva allora l’estrema sinistra) non si sarebbe piegato al ricatto delle BR e che per salvare se stesso avrebbe sacrificato l’uomo che si prevedeva essere destinato a diventare il nuovo presidente della Repubblica dopo il non esaltante mandato di Giovanni Leone. E così l’Italia dei guelfi e ghibellini si divise in falchi e co- lombe, in partito della fermezza e partito della trattativa. La DC- Governo-Stato respingeva il cosiddetto attacco al cuore dello Stato in nome della fredda ragion di Stato ma anche della ragion di partito, mostrando la propria inutile durezza e di avere un cuore così freddo da sacrificare il suo più prestigioso leader in nome della conservazione e della continuità del proprio
potere e, allo stesso tempo, in nome della logica della sovranità limitata che, forse, impose il male minore dell’auto-golpe per evitare il peggio, cioè uno scenario di tipo cileno, simile a quello che si ebbe con Allende nel 1973. Il tutto, natural- mente, nel più completo accordo tra le due Superpotenze e con reciproci vantaggi. Si pensi che, nell’annus horribilis del 1978, proprio durante i 55 giorni, l’America rinunciò alla spa- ventosa bomba N (ai neutroni), tanto osteggiata dall’URSS, e che chiuse un occhio sul colpo di Stato filosovietico in Af- ghanistan dove, di lì a poco, Mosca l’avrebbe fatta da padro- na per poi doversene scappare nel 1989.
In effetti, tra i tanti perché e i tanti dubbi dell’affaire Moro c’è, tra i principali, questo: chi volle impedire a Moro (che già nel 1971 era stato un papabile) di diventare il naturale successore di Leone alla Presidenza della Repubblica? Per- ché, certo, da quello scranno, Moro sarebbe stato l’autorevolissimo garante dei futuri governi basati sull’accordo tra DC e PCI. E questo, secondo una certa logica, andava assolutamente impedito.
La verità è che chi aveva progettato l’operazione via Fani aveva progettato tutto, fin nei minimi particolari, e quella che viene fatta a partire dal 16 marzo sembra la cronaca di una morte annunciata e certo, Moro, pur sperando fino alla fine nella salvezza, aveva intuito che dallo pseudo carcere del popo- lo, dopo uno pseudo-processo, non sarebbe uscito vivo. E, così, a Moro fu imposta una crudele legge del contrappasso per analogia e costretto a vivere il suo inferno su questa terra proprio quando avrebbe dovuto godere del trionfo politico prima con l’operazione del nuovo governo con il PCI nella maggioranza parlamentare e poi con l’elezione a Presidente della Repubblica con i pieni voti dei comunisti. Il contrappasso consiste in questo: come per 55 giorni Moro aveva strenua- mente lavorato per mettere in piedi il primo governo con i
comunisti dopo il 1947, così per 55 giorni avrebbe dovuto patire ed essere umiliato per poi venir assassinato e deposto come un oggetto, come una cosa dentro al bagagliaio di una Renault 4 rosso-amaranto, simbolicamente, tra le sedi del PCI e della DC…
La coraggiosa svolta di Moro diretta alla piena legittima- zione del PCI, che viaggiava insieme a quella della difesa del- la sovranità e della dignità nazionali nei confronti degli alleati americani ed europei, non poteva essere tollerata dagli am- bienti e dai settori più conservatori e reazionari del nostro paese. Moro era troppo in avanti con le idee, stava antici- pando la caduta del Muro di Berlino e, pertanto, per la sua hybris, per aver oltrepassato i limiti invalicabili e, insomma, per il suo senso di sfida avrebbe pagato un prezzo altissimo e sareb- be stato costretto a bere il calice amaro (come, una volta, pa- recchi anni prima, si trovò a dire) fino alla feccia. Le idi di mar- zo erano giunte anche per l’uomo che possedeva il senso del timone unito a un’estrema lucidità e intelligenza delle cose. Qualità che mostrò anche durante la prigionia, senza però es- sere compreso da una classe politica che sembrava essere diventata orribilmente ottusa e mediocremente arroccata sulla inerte e inconcludente linea della fermezza e del discredito di Moro, cioè della parallela negazione di ogni valore alle pa- role del leader democristiano al solo fine di negare una trat- tativa che l’avrebbe salvato.
Dopo quasi quarant’anni da via Fani, risultano, purtrop- po, ancora attuali le parole del Capo dello Stato, Sergio Mat- tarella che, il 24 febbraio del 2017, ha detto che sulla tragica fine di Moro è ancora necessario diradare zone d’ombra. E questo conferma che sull’affaire non tutto è chiaro e che il caso resta aperto non solo e non tanto per la verità giudiziaria ma per quella politica: dopo 40 anni manca ancora, da parte di una classe politica che ha sempre cercato di rimuovere, di dimenti-
care l’ingombrante affaire Moro, la volontà e il coraggio mora- le e politico di cercare la verità e di dirla al paese. Verità che andrebbe detta anche su tutti gli altri delitti, misteri e segreti della Repubblica. La Commissione guidata dall’on. Fioroni ha fatto tutto quel che ha potuto ed è incredibile come quasi tutta la stampa abbia fatto calare una inspiegabile pesante cortina di silenzio sugli esiti dei lavori anche nel quarantesi- mo anniversario del tragico evento. È la conferma che si preferisce, ancora una volta, rimuovere il caso Moro ed è stato amaro vedere che nei documentari televisivi si è dato molto spazio ai brigatisti Morucci-Faranda-Moretti-Gallinari che hanno confermato le loro versioni di sempre, che non dico- no nulla sulla vera verità del caso Moro.
In conclusione, la figura di Moro e i 55 giorni sono una vera e propria metafora, anzi un’allegoria dell’Italia e del suo destino storico-politico, e cioè come in Moro e in quei tragi- ci giorni ci siano racchiusi tanta storia e come il tutto finisca per essere una straordinaria sintesi, uno spaccato della civiltà italiana (nell’aspetto storico, politico, sociale e culturale) so- prattutto di quella del secondo dopoguerra. Inoltre, il caso Moro non è semplicemente un fatto del 1978 e basta, non ha solo cambiato le sorti politiche del paese nel breve periodo ma anche nel medio e lungo periodo. Il caso Moro costituisce un vero e proprio spartiacque nella storia del nostro Paese e una ferita tuttora non risarcita. Senza il caso Moro, probabil- mente, non ci sarebbe stato il craxismo, non ci sarebbe stata Tangentopoli e forse neppure tutto quel che è venuto dopo: chissà come sarebbe stata l’Italia di Moro e Berlinguer! Cer- tamente migliore di quella che è stata dopo via Fani, quando la Prima Repubblica era praticamente morta con l’anatema di Moro contro la Dc e i democristiani che non lo avevano sa- puto o voluto salvare (il mio sangue ricadrà su di voi), mentre il suo fantasma chiedeva e continua a chiedere che sia fatta
giustizia e verità. Una giustizia e una verità che forse solo la letteratura – alla quale attribuisco l’arduo compito di ristabi- lirle facendole trionfare – può rendere a Moro e alle altre vittime di quell’oscuro 1978.
Al lettore affido queste pagine scritte per non dimentica- re. Per non dimenticare le tante vittime, le tante vite coin- volte in una vicenda terribile sia durante che dopo i 55 giorni e per non dimenticare il caso di un uomo che fu brutalmen- te eliminato dalla scena politica perché divenuto troppo scomodo e sul quale le classi dirigenti del nostro paese han- no preferito far prevalere l’oblio piuttosto che una ardua ma illuminante riflessione che avrebbe certo anche tolto qual- che scrupolo di coscienza. E questo perché l’operazione verità, cioè affrontare il caso Moro fino in fondo, con tutto quel che implica politicamente, fa tuttora paura, proprio perché tocca le coscienze (non solo quelle degli uomini politici) e, allora, forse è meglio che sull’affaire non venga fatta piena luce. Perché fare piena luce potrebbe rivelarsi rischioso se non pericoloso e, dunque, è meglio che tutto continui con un annuale innocuo omaggio e ricordo delle vittime di via Fani, magari con qualche brigatista (come Barbara Balzerani, per. es.) che si permette di fare ironia sui noiosi fasti del quaran- tennale e di sbeffeggiare le vittime del terrorismo che per me- stiere… fanno le vittime.
Salvatore La Moglie