
Trebisacce-27/04/2022: Rubrica letteraria a cura di Salvatore La Moglie



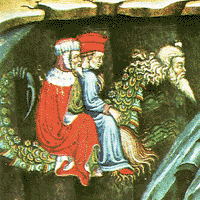



Rubrica letteraria a cura di Salvatore La Moglie
Pubblichiamo qui di seguito l’analisi del XVII canto dell’Inferno di Dante, del quale Salvatore La Moglie propone un nuovo e originale commento che è diventato un libro pubblicato dalla casa editrice Setteponti di Arezzo. Questa volta i protagonisti sono gli usurai e il tema è, ancora una volta, di scottante attualità. Dopo, Dante e Virgilio saranno traghettati in Malebolge dal terribile mostruoso Gerione, simbolo della Frode e della Malizia all’ennesima potenza.
Il canto-capitolo XVII. Cerchio settimo, terzo girone. Siamo sempre nel mondo della Malizia e della Violenza. Gerione, custode dell’ottavo cerchio. I violenti contro Dio nell’arte: gli usurai. Sono eternamente seduti sotto la pioggia di fuoco e portano sul collo emblematiche borse (quelle in cui tenevano il denaro preso ad usura), borse con l’effige dei loro poco onorevoli stemmi gentilizi. Discesa dei due Poeti al cerchio ottavo, il cerchio di Malebolge, sul groppone del ripugnante Gerione.
Ecco la fiera con la coda aguzza, che passa i monti, rompe i muri e l’armi; ecco colei che tutto ‘l mondo appuzza! A presentare con questa severa e indimenticabile esclamazione la terribile malabestia di Gerione, allegoria della Frode, dell’arte dell’inganno, quasi simbolo del Male Assoluto e pestifero del mondo e degli uomini, quel Male che riesce ad attraversare e superare ogni ostacolo e ogni possibile difesa per resistergli, è Virgilio, lo mio duca che, fa cenno al mostro di venire sull’orlo, sul ciglio del burrone, del sabbione, proprio vicino dove finivano gli argini di pietra dove i due Poeti avevano fin allora camminato (e accennolle che venisse a proda vicino al fin de’ passeggiati marmi).
Dante, spesso, continua la narrazione delle sue favolose e incredibili (ma reali!…) storie con incipit di questo genere, con il virgolettato, con il discorso diretto, come a voler mettere subito il lettore in media res, cioè nel cuore di ciò di cui vuol parlare. Ed è tecnica narrativa efficace e che piace, anche perché la avvertiamo come estremamente moderna.
Dunque, vi presento Gerione, la personificazione della Frode, di quel Male che appesta tutto il mondo con la sua puzza disgustosa; Gerione che è un essere mostruoso già nella mitologia classica: un gigante con tre corpi in un unico ventre, figlio di Crisaore e Calliroe; era re dell’isola Eritea e venne ucciso da Ercole (in una delle sue dodici fatiche). La realistica descrizione che Dante fa del mostro infernale è tutta metaforica, allegorica, simbolica e, naturalmente, sta come in atteggiamento di guerra, in posizione di attacco, con la punta velenosa della sua coda aguzza e biforcuta (come quella dello scorpione) che dimena per mostrare che è pronta a colpire: E quella sozza immagine di froda sen venne, ed arrivò la testa e ‘l busto, ma ‘n su la riva non trasse la coda. La faccia sua era faccia d’uom giusto, tanto benigna avea di fuor la pelle, e d’un serpente tutto l’altro fusto; due branche aveva pilose infin l’ascelle; lo dosso e ‘l petto e ambedue le coste dipinti aveva di nodi e di rotelle: con più color, sommesse e sopraposte non fer mai drappi Tartari né Turchi, né fuor tai tele per Aragne imposte. Come talvolta stanno a riva i burchi, che parte sono in acqua e parte in terra, e come là tra li Tedeschi lurchi lo bivero s’assetta a far la sua guerra, così la fiera pessima si stava sull’orlo che, di pietra, il sabbion serra. Nel vano tutta sua coda guizzava, torcendo in su la velenosa forca ch’a guisa di scorpion la punta armava. Dunque: Quella sporca, disgustosa e spaventosa immagine della frode si avvicinò a noi, con la testa e il busto fino al margine ma non la coda (pronta a colpire e lanciare il veleno; cioè la coda è come nascosta perchè simboleggia l’insidia che nasconde chi vuole frodare). Il suo volto era quello di un uomo giusto, retto (proprio di colui che sa ingannare), e (infatti…) il suo aspetto esteriore appariva benevolo e umano mentre il resto del corpo era a forma di serpente (l’ingannevole e diabolico rettile di biblica memoria!…); aveva due zampe artigliate e piene di peli fino alle ascelle (zampe simili a quelle del leone); il dorso, il petto e i fianchi erano variegati, cosparsi di dipinti, di qualcosa di simile a tatuaggi, con striature come annodate e con disegni circolari (nodi e rotelle, ovvero i lacci e i raggiri, le astuzie, gli inganni e le insidie di chi è maestro nell’arte della frode); con maggior varietà di colori, disegni sia nel fondo che nella parte rilevata, in rilievo, non crearono mai tessuti simili i Tartari e neppure i Turchi (così esperti nell’arte della tessitura), né furono mai create da Aracne tele con disegni così complicati e intrecciati (Aracne, mitica tessitrice della Lidia che, volendo sfidare Minerva, fu da questa trasformata in ragno).
Dopo questa similitudine ne segue un’altra con due come: come talvolta le piccole barche a remi stanno ferme sulla riva con una parte nell’acqua e un’altra sulla terra, e come nelle zone settentrionali dove vivono gli ingordi, golosi, ghiottoni Tedeschi (e anche ubriaconi, così erano visti allora), il castoro (bivero) si prepara, si predispone all’assalto dei pesci (standosene con il corpo sulla terra e la coda nell’acqua) così, allo stesso modo stava Gerione (la fiera pessima, perché simbolo del peggiore dei Mali del mondo: la Frode) sull’orlo dell’argine pietroso che recinge, circonda il terzo girone (dove c’è il sabbione) del settimo cerchio (cioè, tende il suo agguato alla ignara preda, alla vittima di turno). Gerione dimenava tutta la sua coda nel vuoto, nell’aria, torcendo verso l’alto la biforcuta e velenosa punta armata di aculei come quella dello scorpione. In cauda venenum, si dice anche per altre situazioni e, in Gerione, il veleno è proprio nella coda, la parte terminale, quella alla quale uno meno pensa che sia e, quindi, è molto insidiosa. La Frode è soprattutto questo: saper nascondere, saper simulare e dissimulare a seconda dei momenti e delle occasioni.
Come in altre occasioni anche qui, ma più delle volte che si sono già viste, il tono polemico di Dante è durissimo perché sempre più durissimo si fa, man mano che si scende nel Basso Inferno, cioè negli abissi del Male, il giudizio e la condanna morale senza se e senza ma. Contro quel Male Assoluto che è la Frode non ci possono essere vie di mezzo, non si può essere assolutori. Già nel Convivio Dante scrive che il traditore, colui che inganna, ne la faccia si mostra amico, sì che fa di sé fede avere, e sotto pretesto d’amistade chiude lo difetto de la inimistate, cioè riesce bene nell’arte dell’inganno, la quale è maggiormente odiosa e ripugnante quando viene messa in opera nei confronti di coloro che si fidano e non sospettano che a loro è tesa una trappola. La frode – scrivono bene i già citati commentatori Fallani e Zennaro – rappresenta un male che dilaga e si diffonde, come la peste, per contagio: il male è penetrato e radicato nelle coscienze umane e nella vita e negli ordinamenti cittadini, perché è sottile, s’insinua, ed è violento nei suoi comandi. Questo ai tempi di Dante, ma non è che oggi le cose siano migliorate, anzi l’arte dell’inganno è universale (come allora…) e in ogni aspetto della vita sociale ed economica ci troviamo di fronte a uomini che ingannano sistematicamente altri uomini, che pensano di notte come ingannare di giorno.
La realista e spaventosa scena di Gerione in atteggiamento minaccioso e aggressivo ci resta scolpita nella mente e sembra di dover ammettere che forse Dante l’ha vista veramente. Virgilio, di fronte a quello scenario, dice a Dante che: Or convien che si torca la nostra via un poco insino a quella bestia malvagia che colà si corca: Ora è necessario che il nostro cammino devii da quello di prima (e cioè proseguire sul lato destro) per poter andare vicino alla malabestia di Gerione, che se ne sta lì ferma: come dire che per una via diritta non si può andare dalla Frode e questo perché, come fece notare, a suo tempo, l’Ottimo, nulla via mena a lei dritta. Perciò, i due Poeti scendono dal lato destro (alla destra mammella) dell’argine e fanno pochi passi sull’orlo pietroso (diece passi femmo in su lo stremo: dieci, per Dante, è anch’esso un numero perfetto) per meglio evitare la sabbia ardente e le fiamme, la pioggia di fuoco (per ben cessar la rena e le fiammelle). E una volta giunti vicino a Gerione, un po’ più oltre Dante vede sulla sabbia infuocata (gente seder propinqua al luogo scemo) anime di usurai sedute vicino al burrone (che è un vuoto abissale che potrebbe ingoiarli). Virgilio dice a Dante che affinchè egli possa avere piena esperienza, conoscenza diretta sul girone degli usurai (la terza categoria dei violenti contro la natura e l’arte), deve andare lì e così potrà vedere il loro stato, la loro condizione (umana…): I tuoi colloqui siano corti, cioè brevi (qui con corti è sottinteso il grande disprezzo di Dante per gli usurai che, apparentemente, prestano denaro per soccorrere il prossimo e, invece, poi chiedono interessi altissimi che li strozzano) e mentre tu farai ritorno, io parlerò con questa (bestia malvagia) cioè con Gerione, affinchè ci conceda di trasportarci sulle sue possenti e robuste spalle (per scendere giù nel burrone e arrivare nell’ottavo cerchio).
Dunque, Dante (dopo i diece passi) cammina tutto solo e pensieroso sopra l’estremo orlo del settimo cerchio per andare dove sedea la gente mesta, dove giacevano per terra le anime sofferenti e tormentate dei dannati. Dante va lì per vedere se c’è qualcuno che conosce e la scena di dolore che ha di fronte è descritta così: Per li occhi fora scoppiava lor duolo; di qua, di là soccorrien con le mani quando a’ vapori, e quando al caldo suolo: non altrimenti fan di state i cani or col ceffo, or col piè, quando son morsi o da pulci o da mosche o da tafani: Il loro dolore si manifestava con scoppio di pianto e con lacrime disperate; si agitavano da una parte e dall’altra cercando, in ogni modo, di ripararsi con le mani dalle fiamme e dalla sabbia ardente, infuocata: proprio come fanno d’estate i cani ora col muso, ora con la zampa quando sono morsi, punzecchiati e molestati da pulci, da mosche o da tafani.
Il disprezzo per questa categoria di peccatori è tale da fargli stabilire il paragone con le sofferenze dei cani durante la calura estiva, che è già per essi una pena: i nobili che si son messi a prestare ad usura con altissimi interessi hanno messo una macchia al loro ceto sociale che, pertanto, è degenerato e caduto nella condizione di viltà di chi, a modo suo, inganna e froda il prossimo con l’usura fatta passare per soccorso economico-finanziario e solidarietà verso coloro che sono in difficoltà. Facciamo nostro il commento del puntuale Sapegno, il quale, dopo aver parlato di studiato realismo dello stile aspro che Dante mette in opera e della materia bassa al quale adegua il significante con l’uso del linguaggio plebeo (sempre più plebeo man mano che si va giù bei bassifondi dell’Inferno), scrive che l’usura è colpita dal poeta, prima ancora che per motivi di ordine religioso e politico, come una manifestazione di viltà. Certo nel suo disprezzo confluiscono in qualche modo tutti gli argomenti agitati allora da una vasta letteratura (…). E senza dubbio egli avvertiva con turbamento la potenza corruttrice del commercio e dell’accumulazione del denaro, fonte precipua di quei sùbiti guadagni, che detestava, strumento di dominio e di sopraffazione a vantaggio di poche famiglie o di singoli individui. Il suo tono fortemente polemico, fino al sarcasmo, nei confronti degli usurai è da mettere in relazione al concetto della gentilezza e all’ideale aristocratico che il Poeta aveva: già nel Convivio (fa notare ancora il Sapegno) Dante lancia i suoi strali contro le “maledette ricchezze”, che sono “naturalmente vili”, “disgiunte e lontane da nobilitade”. Pertanto, gli usurai puniti nell’Inferno sono tutti nobili che hanno macchiato, in un culto ossessivo della ricchezza, la dignità del loro nome (talchè, in Inferno, lo stemma gentilizio avvilito a contrassegno delle borse un tempo pingui, è ridotto a simbolo che sottolinea la loro infamia e mette in rilievo la loro degradazione).
Dante cerca di riconoscerne qualcuno di questi usurai e così scrive: Poi che nel viso a certi li occhi porsi, ne’ quali il doloroso foco casca, non ne conobbi alcun; ma io m’accorsi che dal collo a ciascun pendea una tasca ch’avea certo colore e certo segno, e quindi par che ‘l loro occhio si pasca. E com’io riguardando tra lor vegno, in una borsa gialla vidi azzurro che d’un leone avea faccia e contegno. Poi, procedendo di mio sguardo il curro, vidine un’altra come sangue rossa, mostrando un’oca bianca più che burro. E un che d’una scrofa azzurra e grossa segnato aveva lo suo sacchetto bianco, mi disse: “Che fai tu in questa fossa? Or te ne va; e perché se’ vivo anco, sappi che ‘l mio vicin Vitaliano sederà qui dal mio sinistro fianco. Con questi fiorentin son padovano: spesse fiate m’intronan li orecchi gridando: “Vegna il cavalier sovrano, che recherà la tasca coi tre becchi!”. Qui distorse la bocca e di fuor trasse la lingua come bue che ‘l naso lecchi. E io, temendo no ‘l più star crucciasse lui che di poco star m’aveva ‘mmonito, torna’mi in dietro dall’anime lasse.
Dunque, Dante dice che dopo aver rivolto e fissato lo sguardo, gli occhi nei volti di alcuni dei dannati, sui quali si abbatte il doloroso fuoco infernale, non ne riconosce nessuno; però, si avvede che dal collo di ciascuna anima pendeva una borsa (simbolo del contenitore di denaro dell’usurario, che veniva legato alla cintura) che aveva certo colore e certo disegno (il blasone, lo stemma gentilizio, di famiglia) e di tutto questo sembrava che i loro occhi si nutrissero, si compiacessero (cioè si riempivano gli occhi della vista della loro borsa-blasone, cioè del loro marchio d’infamia). E come man mano Dante arriva vicino a loro e li guarda ben bene, in una di queste borse, che era gialla, vede l’azzurro, cioè in campo giallo-oro vede spiccare il leone azzurro della famiglia fiorentina dei Gianfigliazzi, che furono Guelfi Neri dal 1300 e, soprattutto, grandi usurai. Forse il dannato a cui fa cenno Dante è messer Catello di Rosso Gianfigliazzi, ma al Poeta interessa certamente di più mettere in risalto che ad essere prestatori ad usura era l’intera “nobile” famiglia.
Poi, continuando a guardare ancora (secondo alcuni commentatori, procedendo il mio sguardo il curro, cioè col procedere che faceva il carro del mio sguardo, sarebbe metafora simile a quella della navicella del mio ingegno), dunque, continuando a guardare ancora, Dante vede un’altra borsa-blasone con un’oca bianca più del burro in campo rosso-sangue (lo stemma della famiglia ghibellina degli Obriachi, di cui spiccavano Locco e Ciapo). E poi c’è l’usuraio che porta la sua borsa-blasone con sopra disegnata una scrofa grossa e azzurra in campo bianco. Si tratta dello stemma della famiglia padovana degli Scrovegni e a parlare sarebbe Reginaldo, grande avaro e grande usuraio, fino alla morte attaccato bassamente al suo tanto denaro, che temeva prendesse strade sbagliate. Reginaldo è l’unico a cui Dante concede di parlare: Cosa fai in questa fossa, in questo abisso infernale? Come dire: se non fossi venuto qui, non mi avresti visto tra questi dannati! Ma, ormai, Dante l’ha visto e lui non può che ricordargli che non è solo in quella terribile pena infernale: Ora tu te ne vai, e poiché sei ancora vivo, devi sapere che il mio concittadino Vitaliano (una volta morto) siederà vicino a me sul lato sinistro (come dire: soffriremo insieme!). Pare si tratterebbe di Vitaliano del Dente, podestà di Vicenza (1304) e di Padova (1307), ma si dice che fosse uomo generoso e, allora, i commentatori propendono a vedere nel dannato Vitaliano di Jacopo Vitaliani, noto come famoso usuraio. Il mal nato dice poi di essere padovano in mezzo a tutti gli altri che sono fiorentini, e questa è una sottolineatura voluta da Dante per accentuare la sua polemica contro i suoi corrotti e marci concittadini vivi e morti, i quali ultimi, spesse fiate, spesse volte intronano, stordiscono le orecchie di Reginaldo gridando che, poi, verrà il turno di un altro grande usuraio che dovrà soffrire come un cane sotto la pioggia di fuoco: verrà tra di noi Gianni (o Giovanni) di Buiamonte dei Becchi (il peggiore degli usurai, il cavalier sovrano, gli fa dire Dante, come a voler conferirgli, con tono sferzante e sarcastico, il titolo, poco nobiliare, di capo, principe degli usurai). I Buiamonte avevano nello stemma tre caproni neri (secondo alcuni, tre becchi d’aquila) in campo giallo-oro (la tasca con tre becchi) e Gianni era stato Gonfaloniere di Giustizia nel 1293 e aveva ricoperto più di una carica pubblica; morì due anni dopo la condanna per truffa, nel 1310.
Il tono polemicamente ironico, fino al sarcasmo impietoso, trova il suo epilogo nella miserabile scena di Reginaldo che storce la bocca e tira fuori la lingua come fa il bue quando si vuol leccare il naso, ovvero come quando si fanno le boccacce per farsi beffa di qualcuno. Gesto animalesco, bestiale che mette il sigillo a tanta miserabile e bestiale condizione (umana…) di questi dannati.
Dante, a questo punto, temendo che Virgilio si irritasse per il fatto che restava ancora a parlare con quel gruppo di dannati (e, infatti, lo aveva avvertito di fermarsi a parlare per poco tempo), Dante, dunque, torna indietro allontanandosi dalle anime stanche, abbattute dalla sofferenza e dai tormenti. Il Poeta trova Virgilio già ben posizionato sulla robusta e possente groppa del mostruoso bestione (trova’ il duca mio ch’era salito già sulla groppa del fiero animale) e che, quando lo vede, gli dice di essere forte e ardito, forte e coraggioso, perché omai si scende per sì fatte scale: d’ora in poi si procederà con mezzi simili a questo per scendere (giù nel Basso Inferno e, infatti, poi ci saranno Anteo e Lucifero). Virgilio dice ancora a Dante di stare davanti e lui al centro (monta dinanzi, ch’i’ voglio esser in mezzo) in modo che la coda non possa far male: la Ragione vuole proteggere Dante dalle possibili, improvvise e imprevedibili insidie della Frode, che potrebbe lanciare il suo velenoso attacco.
Segue una delle stupende similitudini a cui Dante ci ha abituato sin dalle prime terzine: Qual è colui che sì presso ha ‘l riprezzo della quartana, c’ha già l’unghie smorte, e triema tutto pur guardando il rezzo, tal divenn’io alle parole porte; ma vergogna mi fe’ le sue minacce, che innanzi a buon segnor fa servo forte: Come colui che sente avvicinarsi i brividi della febbre quartana, e ha già le unghie pallide e trema per tutto il corpo solo a guardare i luoghi ombrosi e freschi, così diventai dopo le parole dette da Virgilio; ma la vergogna di apparire vile, dopo il suo incitamento, mi fece diventare coraggioso e valoroso, come succede al servo con il suo valente signore (tipica della concezione medievale).
Sia detto per inciso, quando Dante descrive i sintomi della febbre quartana fa pensare alle febbri che dovette avere dopo che fu colpito dalla malaria presa nelle paludi di Comacchio, durante un’ambasceria a Venezia per ordine di Guido Novella da Polenta, Signore di Ravenna, dove morirà nel 1321.
Fattosi forte e coraggioso, Dante si posiziona, si sistema (i m’assettai) sopra quelle spallacce, cioè sul groppone infido di Gerione, e avrebbe voluto dire, a voce alta, a Virgilio, un abbracciami forte! (per sentirsi più sicuro) ma non gli viene bene come avrebbe voluto (sì volli dir, ma la voce non venne com’io credetti: “Fa che tu m’abbracce”). Virgilio (la Ragione umana), che altre volte è venuto in soccorso di Dante in altre situazioni pericolose, rischiose (ch’altra volta mi sovvenne ad altro forse), non appena il Poeta monta sul dorso della malabestia, lo abbraccia e lo stringe forte come a volerlo proteggere dalle insidie del Regno della Frode contro cui solo la Ragione può costituire il più solido e sicuro baluardo (tosto ch’io montai con le braccia m’avvinse e mi sostenne). E, dopo il sicuro abbraccio, Virgilio comanda a un bestione reso docile dal fatto che gli avrà certamente detto che il viaggio di Dante è voluto da Colui che può ciò che vuole, comanda di mettersi in moto: Gerion, moviti omai: le rote larghe, e lo scender sia poco: pensa la nova soma che tu hai: Gerione, muoviti e bada che siano larghi i giri e lenta la discesa, perché devi tener conto dell’insolito peso, carico umano: come dire: guarda che Dante è in carne ed ossa e un tuo brusco movimento potrebbe danneggiarlo, metterlo in pericolo.
Gerione sembra aver compreso bene e la partenza su quello strano dirigibile (insieme ai pensieri, alle sensazioni ed emozioni di Dante) è meravigliosamente e fantasticamente descritta così nelle ultime terzine del canto-capitolo: Come la navicella esce di loco in dietro in dietro, sì quindi si tolse; e poi ch’al tutto si sentì a gioco, la v’era il petto, la coda si rivolse, e quella tesa, come anguilla, mosse, e con le branche l’aere a sé raccolse. Maggior paura non credo che fosse quando Fetòn abbandonò li freni, per che ‘l ciel, come pare ancor si cosse; né quando Icaro misero le reni sentì spennar per la scaldata cera, gridando il padre a lui “Mala via tieni!”, che fu la mia quando vidi ch’i’ era nell’aere d’ogni parte, e vidi spenta ogni veduta fuor che della fera. Ella sen va notando lenta lenta: rota e discende, ma non me n’accorgo se non che al viso e di sotto mi venta. Io sentìa già dalla man destra il gorgo far sotto noi un orribile scroscio, per che con li occhi ‘n giù la testa sporgo. Allor fu’ io più timido allo stoscio (altri preferiscono: scoscio), però ch’i’ vidi fuochi e senti’ pianti; ond’io tremando tutto mi raccoscio. E vidi poi, chè nol vedea davanti, lo scender e ‘l girar per li gran mali che s’appressavan da diversi canti. Come ‘l falcon ch’è stato assai sull’ali, che sanza veder logoro o uccello fa dire al falconiere “Ohimè, tu cali!”, discende lasso onde si move snello, per cento rote, e da lunge si pone dal suo maestro, disdegnoso e fello; così ne puose al fondo Gerione al piè al piè della stagliata rocca e, discarcate le nostre persone, si dileguò come da corda cocca.
Dunque: Come una piccola nave si stacca dalla riva e indietreggia a poco a poco per andare in acqua, allo stesso modo Gerione si staccò dall’orlo e, quando si sentì pienamente a suo agio, si girò su se stesso invertendo la rotta, la direzione di marcia (come una barca, rivolse la prua dove prima era la poppa) e come un’anguilla mosse la coda e con le branchie raccolse dentro di sé tutta l’aria (perché è come se nuotasse nell’aria). Dante dice di non credere che la paura provata da Fetonte e poi da Icaro sia stata superiore a quella provata da lui in quel momento, quando Gerione spicca il suo volo nell’atmosfera dell’abisso infernale: no, la sua è stata una paura più grande di quella provata da Fetonte (figlio di Apollo, dio del Sole) quando non riuscì a frenare i cavalli del carro del sole (che il padre gli aveva concesso di guidare nel cielo) e una striscia del cielo si bruciò, prese fuoco e ancora oggi se ne vedono i segni (con la formazione della Via Lattea; per questo suo errore, Fetonte fu fulminato da Giove e finì nel fiume Eridano). E non provò certo la mia paura neppure il povero Icaro, quando vide staccarsi le ali incollate dal padre Dedalo con la cera: spiccando il volo nel cielo, per fuggire dal Labirinto di Creta, Icaro si avvicinò troppo al sole, tanto da far sciogliere la cera e precipitare in mare. Eccitato dall’esperienza insolita del volo, Icaro non seguì il consiglio del padre di seguire la giusta rotta e si spinse troppo in alto verso il sole: Dedalo gli urlò invano: Mala via tieni! (stai sbagliando direzione!…).
Ma queste paure sono ben poca cosa, dice Dante, a paragone di quella provata da me quando mi avvidi che ero nell’aria, nel vuoto dell’abisso infernale e non vedevo nient’altro fuorchè il mostruoso Gerione. Il quale planava piano piano, lentamente (così come gli aveva ordinato Virgilio): gira, ruota e discende e non me ne accorgo se non per il fatto che sul volto e nella parte inferiore mi arriva aria, una sorta di alito di vento sollevato dai suoi pur lenti giri a spirale della fiera. Dante sente dal lato destro l’orribile fragoroso, rumoroso, e vorticoso precipitare della gran massa di acque del Flegetonte, che dal settimo cerchio finisce nell’ottavo e, per questo, sporge la testa verso il basso per poter vedere coi suoi occhi il terrificante spettacolo. La scena si fa sempre più terrorizzante e Dante ha paura di scendere, di saltar giù dal possente groppone di Gerione: più si va giù negli abissi infernali (e in quelli della mente e del cuore degli uomini…) e più il dolore e le sofferenze per i peccati e il Male commessi sulla terra sono maggiori. E, infatti, subito dopo, spiega perché ha tanta paura di scendere, tanto da aggrapparsi sempre più forte con le gambe, con le cosce al dorso della malabestia: per il fatto di vedere fiamme, fuoco e sentire voci di dolore, tormento e pianto dei dannati. Dante dice, poi, di vedere cose che prima non era riuscito a vedere, e cioè lo scendere e il ruotare, girare attraverso i grandi peccati, i grandi mali ciascuno in parti diverse, a seconda del luogo (girone) di destinazione. Il viaggio sul dorso di Gerione è terminato e la fiera con la coda velenosa alla punta è ormai impaziente e vuole deporre a terra il carico che è stato costretto ad accogliere sul suo groppone. Dante racconta la scena con una similitudine, istituendo il paragone con il falcone (il Poeta conosceva l’opera di Federico II di Svevia De arti venandi cum avibus, L’arte di cacciare con gli uccelli, ma probabilmente la realistica scena che segue era stata mutuata dalla sua diretta esperienza): Come il falcone che ha volato troppo ed è stanco, che senza il richiamo di un finto uccello (costruito apposta come esca) o di una preda da acciuffare al volo, fa dire al falconiere (deluso) ahimè, mi dolgo che tu scenda! (perché non ha retto alla prova), ebbene come questo falcone discende stanco al luogo da dove è solito muoversi veloce e agile, con giri e giravolte infiniti e si pone lontano dal suo falconiere irato e incattivito perché senza preda, così, allo stesso modo, con la stessa rabbia impotente (perché la Frode non è riuscita ad acciuffare Dante, protetto com’è dalla Ragione e dalla Grazia di Dio): Gerione ci depone, ci scarica proprio ai piedi, rasente la roccia dirupata del burrone, tagliata a picco e che scende come a precipizio, in maniera verticale al cerchio di Malebolge, e se ne va veloce come una freccia che viene fatta scoccare da un arco.
Il bestione infernale sparisce veloce, in un lampo dalla scena: è infastidito e crucciato perchè senza preda, a bocca asciutta e ritiene tempo perduto quello a cui è stato costretto da Dio a trascorrere nel trasporto dei due Poeti nell’ottavo cerchio e in quell’orribile luogo chiamato Malebolge. Intanto, Dante ha superato anche quest’ultima paura insieme al dubbio e al sospetto di riuscire a proseguire il suo viaggio nel cuore della notte della mente e dell’animo umano.


